Guerra giusta e diritto internazionale: da Grozio a Putin
Con Carlo Galli, Antonio Del Vecchio, Geminello Preterossi. Incontro moderato da Giuseppe Di Leo e andato in onda su «radioradicale.it» il 24 aprile 2023
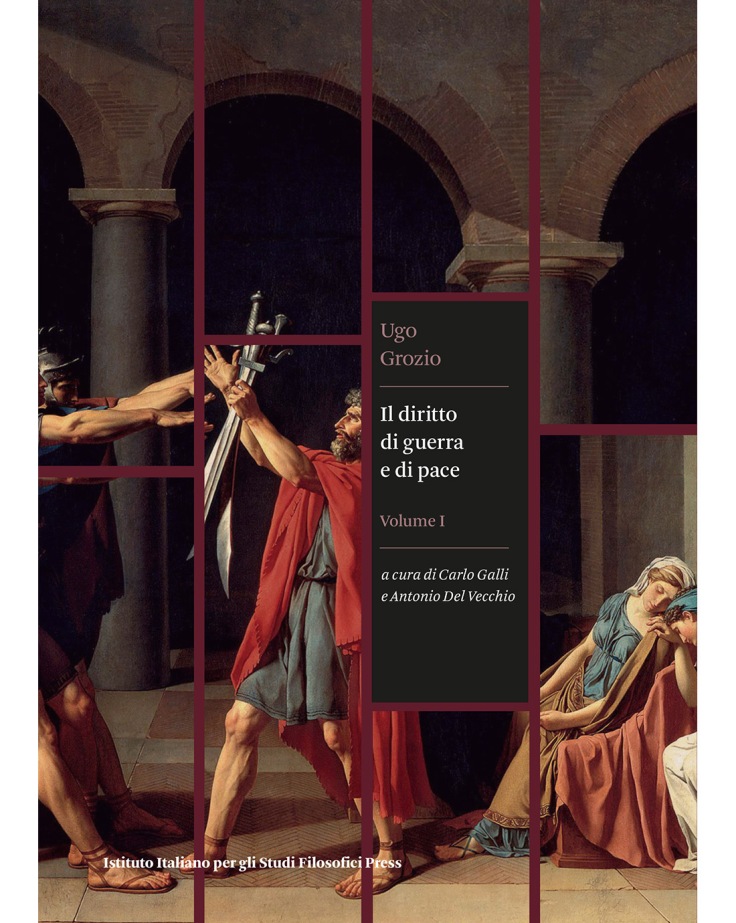
Video
Gazzetta incontra… la filosofia politica
Intervista a cura di Pasquale Noschese, 23 novembre 2020.
Neoliberismo e ordoliberismo: caratteristiche e problemi da un punto di vista filosofico-politico
Lezione online trasmessa il 25 giugno 2020 sul canale YouTube dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.
Diagnosi di una crisi politica
Intervista con Michele Linfozzi, trasmessa l’11 maggio 2020 sul canale YouTube dell’associazione «Sottosopra».
Democrazia di massa o degli individui? Un’alternativa problematica
Intervento tenuto a Pordenone l’11 gennaio 2020, nell’ambito del ciclo di incontri «Popolo e democrazia. Approfondimento su una relazione complessa», organizzato dall’Associazione «Norberto Bobbio» – Università della Politica.
Sovranità e sovranismo
Intervista con Matteo Cerri pubblicata in «cerriblog.com» il 25 novembre 2019

Vai alla pagina
La politica e il suo spazio. Carlo Galli a Nomos
Intervista con Valerio Salvini realizzata per «Radio Città del Capo» il 27 ottobre 2019.

Ascolta
«Perché non possiamo non dirci sovrani»
Intervento tenuto a Montesilvano (PE) il 26 ottobre 2019 in occasione del convegno internazionale «Euro, mercati, democrazia 2019 – Decommissioning EU», organizzato da A/Simmetrie.

Video
Comunicazione come politica, politica come comunicazione
Intervento tenuto a Bologna il 9 ottobre 2019 nell’ambito del «Pandora Rivista Festival», in collaborazione con la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, e pubblicato nel sito di Radio Radicale.

Video
Ordoliberalismo e marxismo, ieri e oggi
Dibattito andato in onda su Radio Radicale l’11 settembre 2019 in occasione della pubblicazione dei fascicoli 1 e 2 del 2019 della rivista «Filosofia politica». Con Carlo Galli, Paola Rudan, Adelino Zanini, Olimpia Malatesta. Ha dialogato con gli autori Giuseppe Di Leo.

Ascolta
«Sovranità» di Carlo Galli
Intervento tenuto il 6 settembre 2019 a Frattocchie (Roma) nell’ambito della scuola estiva di formazione politica «Il ritorno della politica», organizzata da «Patria e Costituzione» e da «Senso Comune».

Video pubblicato nel sito di Radio Radicale
«Sovranità» di Carlo Galli
Presentazione dell’ultimo libro di Carlo Galli organizzata a Roma da «Patria e Costituzione» il 26 giugno 2019. Con Stefano Fassina, Gianni Cuperlo, Monica Di Sisto e Alfredo D’Attorre.
Video pubblicato nel sito di Radio Radicale
Intervista a Carlo Galli sul suo libro «Sovranità»
di Giuseppe Di Leo

In Radio Radicale, 12 giugno 2019
Carlo Galli, «Sovranità»
In occasione della pubblicazione di Sovranità (Bologna, il Mulino, 2019, pp. 154), Carlo Galli dialoga con Francesco De Sanctis e Geminello Preterossi. Incontro organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 21 maggio 2019).
Carlo Galli a «RomaInConTra»
Intervista con Enrico Cisnetto (Roma, 6 maggio 2019), in occasione della pubblicazione di «Sovranità» (il Mulino 2019)
PRIMA PARTE
SECONDA PARTE
TERZA PARTE
QUARTA PARTE
Sovranità. Contro l’utopia della «politica liquida»
Intervento tenuto a Genova (Palazzo Ducale) il 4 maggio 2019 nell’ambito della manifestazione «I giorni del LIBRO PICCOLO». Dialoga con l’Autore Michela Bompani.
Sovranità
Intervento tenuto a Camerino l’8 aprile 2019 in occasione della presentazione di Francescomaria Tedesco, Sovereign Excess, Legitimacy and Resistance (Routledge 2018).
PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA
“Contingenza e necessità nella ragione politica moderna” (Laterza 2009)
Lezione tenuta all’Istituto Avventista di Cultura Biblica “Villa Aurora” – Facoltà di Teologia, nell’ambito dell’incontro “Libro-amico” organizzato dal Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose e moderato da Hanz Gutierrez (Firenze, 20 febbraio 2019).

Carlo Galli, Contingenza e necessità nella ragione politica moderna
“Homo sacer”
Intervento tenuto a Napoli il 29 novembre 2018, presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici, in occasione della pubblicazione dell’edizione integrale di Homo sacer (Quodlibet 2018) di Giorgio Agamben.
Carlo Galli, “Marx eretico”
In occasione della pubblicazione di Marx eretico (Bologna, il Mulino, 2018, pp. 164), Carlo Galli dialoga con Laura Bazzicalupo e Geminello Preterossi; modera Fiorinda Li Vigni. Incontro organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, 28 novembre 2018).
Presentazione di “Marx eretico” a Firenze
Intervento tenuto a Firenze il 14 novembre 2018, nell’ambito dell’incontro coordinato da Antonio Floridia e organizzato da CRS (Centro per la Riforma dello Stato) Toscana, Circolo Vie Nuove, Diritti a Sinistra Firenze, Istituto Gramsci Toscano.
Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale
Intervento tenuto a Roma il 24 ottobre 2018 in occasione della presentazione del volume di Alessandro Somma Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale (DeriveApprodi 2018) e pubblicato nel sito di Radio radicale.

Destra e sinistra nell’epoca dei populismi e dei sovranismi
Lectio magistralis tenuta a Lecce il 15 settembre 2018 in occasione di «Democrazia è» – quinta edizione delle «Giornate del lavoro» della CGIL -.
L’Italia dopo il voto
Intervista con Caterina Parise di Askanews (Roma, 21 marzo 2018)
Dichiarazione di voto effettuata alla Camera dei deputati il 13 dicembre 2017 per il Gruppo parlamentare Articolo Uno-MDP, nell’ambito della discussione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, n. 29)
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di Moro non ha lavorato inutilmente. Ha indagato una storia di verità mancante, di indagini omesse e inaccurate, di risultanze contraddittorie, di coperture ambigue nel passato e anche nel presente. E questo è ciò che ha portato alla luce.
Novità in senso assoluto non ci sono, perché sospetti, incongruenze, c’erano già e sono stati proprio quelli che hanno generato la decisione di istituire la Commissione. E, tuttavia, la Commissione ha prodotto risultati concreti e tangibili. Elenchiamoli brevemente.
È assodata la presenza in via Fani di elementi non afferenti esclusivamente alle Brigate Rosse, elementi afferenti ai Servizi, alla mafia e a Servizi stranieri. È assodato il ruolo particolare, benché ancora oscuro, del bar Olivetti. È assodato, inoltre, che il palazzo di via Massimi 91, alla Balduina, di proprietà dello IOR, è stato utilizzato per spostare Moro dalle auto che lo hanno rapito in via Fani ad altre sulle quali fu trasferito o forse, addirittura, è stato adoperato come prigione dell’onorevole Moro. È stato assodato che il covo di via Montalcini non è stato utilizzato. È stato assodato che la morte di Moro non è avvenuta nelle modalità in cui è stata raccontata da i brigatisti, che forse non vi hanno nemmeno preso parte. È stato assodato che l’arresto di Morucci e Faranda è avvenuto in modalità diverse da quelle che erano emerse dagli atti giudiziari. È stato assodato che la latitanza di Alessio Casimirri è qualche cosa di molto, molto grave, poiché in essa non sono presenti soltanto le protezioni dovute al regime sandinista di allora, ma con ogni verosimiglianza anche di organismi dei Servizi italiani. È stato assodato che la stessa iniziativa del Pontefice fu boicottata e che le trattative vaticane furono misteriosamente interrotte.
Da tutto ciò emerge che il caso Moro è parte integrante, e probabilmente culminante, della strategia della tensione nel nostro Paese – sostanzialmente un golpe – ; quella strategia nata da piazza Fontana, che ha determinato, oltre a innumerevoli morti e infiniti lutti, un cambiamento radicale dello svolgimento della politica del nostro Paese, cambiamento che è stato sottratto alla libera determinazione delle istituzioni democratiche. È stata assodata la dimensione internazionale del caso Moro, sia quella mediterranea, sia quella, diciamo così, occidentale e con ogni verosimiglianza orientale. È stata assodata una commistione fra pezzi dello Stato, criminalità comune, P2 e terrorismo. È stato assodato che il memoriale Morucci è un tassello di una informale trattativa fra lo Stato e le Brigate Rosse, costruita per stabilizzare una sorta di verità parziale, raccontabile, sul caso Moro. La verità che è divenuta verità ufficiale – quel memoriale in cui, sostanzialmente, le BR si assumono l’unica ed esclusiva responsabilità del caso Moro, escludendo ogni interferenza esterna -, quel memoriale è sostanzialmente falso.
Insomma, la Commissione ha prodotto il risultato che ha sgomberato il campo da false piste e ha segnalato all’autorità giudiziaria nuove piste di indagine. Certo, il lavoro della Commissione resta parziale, mancano ancora molti punti oscuri che devono essere chiariti. Certo, ci voleva più tempo, era necessario più tempo per i lavori della Commissione. Era necessario che si potesse giungere ad una relazione finale: quella della quale si sta parlando è la terza relazione sullo svolgimento dei lavori.
In ogni caso, nonostante queste debolezze, il lavoro è un lavoro forte, convincente. I lavori di questa Commissione non sono stati una caccia ai fantasmi. Piuttosto, sono stati dissolti i fantasmi di parecchie menzogne e si è fatto qualche passo per placare, dandogli corpo, il fantasma che dovrebbe perseguitare tutti i democratici: il fantasma della verità non ancora acclarata, il fantasma di una verità che l’Italia, dopo quasi quarant’anni, due generazioni, sta ancora contemplando come si contempla una ferita ancora aperta; un’Italia che, nello strano silenzio dei media, nelle sue istituzioni non cessa ancora di indagare – ed è giusto che sia così -, non cessa di tentare di far luce su quello che è il punto cieco della propria storia repubblicana, su quel punto di svolta che ha bloccato uno sviluppo intelligente della nostra vita democratica. Un blocco che ancora oggi ci segna. Stiamo ancora cercando definitivamente la verità, benché ad essa ci sia stata una importante approssimazione. E finché la verità non sarà tutta evidente, finché qualche cosa resterà oscuro, si tratterà di un’oscurità, di un’ombra che grava sulla democrazia. C’è ancora lavoro da fare per dissipare quell’ombra, e tuttavia il lavoro che è stato fatto da questa Commissione merita il voto favorevole del gruppo parlamentare MDP alla risoluzione del governo.
Weimar: laboratorio di che cosa? Liberalismo, democrazia, plebiscitarismo
Conferenza di apertura del II Congreso Internacional Populismo Global, Laboratorio Weimar: La crisis de la primera globalización en Euroamérica (1918-1933), Universidad Complutense de Madrid, 13 novembre 2017

Intervento tenuto in Aula, alla Camera dei deputati, il 12 ottobre 2017 (seduta 869) in occasione dell’esame della legge elettorale
Signora Presidente, onorevoli colleghi,
l’ordine del giorno n. 9/2352-A/R/131, che illustro, impegna il governo a valutare la portata degli effetti applicativi di alcune norme della legge che è in corso di approvazione, e precisamente dei commi 6, lettera b), 8 e 14, lettera a) dell’articolo 1, che prevedono l’obbligo di deposito dello statuto, ovvero di una dichiarazione, attestanti i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di un’eventuale ricusazione delle liste stesse; e del comma 10, lettera e), che detta disposizioni relative all’alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali. Poiché questi commi intervengono sui principi di cui agli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione, noi chiediamo l’approvazione di questo ordine del giorno, nel quale ci facciamo carico di una preoccupazione generale: il fatto che questa norma elettorale, per quanto riguarda il merito e per quanto riguarda il metodo, pone gravi problemi probabilmente di costituzionalità, sicuramente di rispetto sostanziale dei fondamenti della democrazia liberale.
Per quanto riguarda il merito, infatti, alcune sue caratteristiche sono assolutamente estranee alla democrazia liberale. Si parla, ad esempio, del divieto di voto disgiunto; si parla, ad esempio, del fatto che le candidature sono tutte bloccate, e il Parlamento che uscirà da queste nuove elezioni, con questa nuova legge elettorale, sarà un Parlamento esclusivamente composto di nominati; si parla della curiosissima modalità di attribuzione del cosiddetto «voto disperso», cioè del voto conferito esclusivamente al candidato nel collegio uninominale.
Per quanto riguarda il metodo d’approvazione, poi, è assolutamente evidente che in questa circostanza, come in un’altra circostanza due anni fa, il Parlamento è di fatto espropriato della propria caratteristica fondamentale: di parlare; di discutere apertamente e liberamente di una norma. L’apposizione della fiducia sopra la legge elettorale, infatti, è qualche cosa che si era vista due volte nei novant’anni che ci precedono: una volta a opera del fascismo; una volta a opera della Democrazia Cristiana, per quanto riguarda la cosiddetta «legge truffa». Legge Acerbo e «legge truffa»: in novant’anni due occasioni di posizione della questione di fiducia sulla norma elettorale.
Negli ultimi due anni, invece, la fiducia è stata posta per due volte. Un’accelerazione che ci dice una cosa molto semplice: che la centralità del Parlamento, l’indipendenza del Parlamento, la sua funzione di rappresentante della sovranità del popolo, vengono progressivamente, e con grande accelerazione, meno. Questa legge elettorale ha compiuto il miracolo di togliere sovranità tanto al popolo – che in effetti fuori da quest’Aula protesta -, quanto ai deputati, e ha conferito e conferisce la sovranità – cioè il diritto, la facoltà, di nominare le Camere – a una ristrettissima oligarchia partitica. Il che avviene, a maggiore ironia, nel momento in cui i partiti sono più deboli, e si arroccano dentro queste mura perché non sono più in grado di gettare uno sguardo critico, uno sguardo propositivo, fuori da queste mura. È un momento molto brutto, signora Presidente, per la nostra democrazia.
Europa, democrazia, Stati
Intervento tenuto alla tavola rotonda La democrazia in Europa: prospettive sull’Unione, organizzata a Pisa il 16 settembre 2017 dalla Scuola Normale Superiore per la «Giornata in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi. A un anno dalla scomparsa», e pubblicato nel sito di Radio Radicale.

Dichiarazione di voto fatta da Carlo Galli (Articolo Uno-MDP) alla Camera dei deputati mercoledì 2 agosto 2017, sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alla missione internazionale in supporto alla Guardia Costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2) (Doc. XVI, n. 4)
Signora Presidente, onorevole colleghi,
la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla missione italiana a supporto della Guardia costiera libica presenta caratteristiche palesi di criticità, tutte evidenziate nell’atto di indirizzo che Articolo Uno-MDP ha autonomamente presentato.
La esilità giuridica e politica della legittimazione, in primo luogo. Si tratta, infatti, di alcune risoluzioni Onu che prevedono in realtà un quadro d’intervento internazionale, e di una lettera segretata di una personalità (il presidente del Consiglio nazionale libico) internazionalmente riconosciuta ma dal debole potere effettivo. Il che colloca il nostro intervento in un contesto segnato da un alto grado di instabilità politica e militare.
La scarsa chiarezza dell’impegno che ci assumiamo è poi evidenziata nella nozione di «supporto» che è il perno della deliberazione governativa. Una nozione che si presta a molte interpretazioni sul campo, e che da parte nostra abbiamo cercato di determinare e delimitare con esplicite restrizioni, come ad esempio l’esclusione del blocco navale e dell’intervento armato via terra. Esplicitazioni che fanno parte del dispositivo del nostro atto d’indirizzo, e che sono state accolte anche in quello della maggioranza al Senato e messo in premessa in quello della Camera, il che ha segnato un significativo successo della nostra iniziativa politica. Un successo che rivendichiamo apertamente.
Ulteriore criticità è il destino dei migranti, una volta ritornati in Libia per azione della Guardia costiera libica, con il nostro aiuto. È evidente che su questo punto delicatissimo si deve esigere dal governo italiano che si impegni a ottenere da quello libico le più stringenti garanzie che essi vengano trattati sulla base irrinunciabile del diritto internazionale umanitario. E si deve altresì agire perché si attivino organizzazioni come UNHCR e OIM, e perché queste siano responsabili della supervisione diretta dei centri d’accoglienza in terra libica.
Infine, la criticità più evidente è che questa operazione – l’estensione di «Mare Sicuro» dentro le acque territoriali libiche – non ha la minima possibilità di affrontare alla radice la questione dei migranti. Sia per la sua esiguità materiale sia perché la questione che vuole affrontare nasce da alcune delle più acute contraddizioni dell’attuale modello di sviluppo planetario, una questione che si nutre di disperazione, di disumanità, di criminalità, e che ha visto tra le proprie cause prossime sia la sciagurata guerra mossa da alcune potenze occidentali alla Libia, che ne ha distrutto la compagine statuale, sia la inerzia della UE riguardo le politiche di gestione dei flussi migratori. Una inerzia europea che si è sostanziata, finora, in promesse disattese, nella inflessibile riaffermazione di regole che scaricano in pratica solo sull’Italia tutto il peso dell’emergenza umanitaria delle migrazioni africane, e che ha generato (non senza nostre responsabilità e imprevidenze) irrigidimenti diplomatici, innalzamenti di muri confinari, rinascita di nuovi nazionalismi e di nuove rivalità anche fra Paesi amici e alleati.
L’Italia, a questo punto, non può non cercare di prendere in mano la situazione, benché gravemente compromessa. Con un’iniziativa non certo risolutiva, a cui è costretta dalle circostanze, con l’umanità e il senso del diritto e della giustizia che ne contraddistinguono l’azione internazionale, ma anche con un convinto senso di responsabilità verso i propri cittadini e verso il proprio interesse nazionale. I cittadini italiani, infatti, già provati da quasi un decennio di crisi economica, hanno il diritto di vedere all’opera una politica capace almeno di chiamare i problemi col loro nome e di sforzarsi di iniziare a risolverli, secondo le proprie possibilità – una pur piccola parte della questione migranti (la lotta contro la criminalità) può essere di competenza dello Stato, ed è giusto che su questa linea ci si impegni -. E la politica ha a sua volta il dovere anche di perseguire l’opera di pacificazione, di messa in sicurezza, di ristabilimento della fiducia e della cooperazione, fra le due sponde del Mediterraneo, che la storia e l’evidenza geopolitica destinano al dialogo più stretto.
È evidente che in questa azione di responsabilità l’opzione che qui si prefigura non è sufficiente, e che questa non dovrebbe essere che un tassello di un ben più ampio sforzo parallelo, comprendente l’attivazione di corridoi umanitari e di canali di accesso protetti riconosciuti dalla UE. Oltre che un’azione internazionale a largo raggio che sappia mettere in prospettiva un’idea di sviluppo compatibile per l’Africa.
Ed è altrettanto evidente che la consapevolezza delle criticità segnalate motiva Articolo Uno a votare, per le parti non assorbite da quella della maggioranza, a favore della propria risoluzione, nella quale le contraddizioni vengono ben evidenziate, e in cui si dà alle ONG il giusto riconoscimento della loro azione benemerita che troppi oggi tengono a criminalizzare; e motiva a dare un voto di appoggio a quella della maggioranza, in un’ottica di assunzione di responsabilità nazionale più che di specifica fiducia verso l’esecutivo. Un appoggio, tuttavia, necessariamente articolato, date le diverse sensibilità presenti, del tutto legittimamente, all’interno del nostro gruppo, particolarmente su un tema tanto complesso e controverso, e davanti a un intervento governativo tanto incerto.
Conferenza stampa di presentazione del ciclo di seminari «Le fonti politiche ideali della democrazia repubblicana», ideato da Carlo Galli e promosso da Articolo Uno – MDP (Roma, 13 giugno 2017)

Intervento di Carlo Galli – che ha aderito da indipendente al Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati «Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista» – alla tavola rotonda dal titolo «Europa, frontiere, identità» (Milano, 20 maggio 2017), coordinata da Gianluigi Paragone, in occasione di «Fondamenta» – l’assemblea programmatica di MDP -. Con Emma Bonino ed Enrico Rossi.
Dichiarazione di voto di Carlo Galli per Sinistra Italiana pronunciata in Aula il 25 gennaio 2017, in occasione della discussione delle Relazioni sull’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
La Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro ha fin qui realizzato un lavoro metodologicamente accurato e preciso − fondato su testimonianze di prima mano, su acquisizioni documentali, sulle indagini effettuate e sugli accertamenti dell’autorità giudiziaria e delle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta −, mostrandosi animata dalla volontà di portare alla luce gli elementi di difficoltà e le domande lasciate aperte dai pur importanti esisti giudiziari del passato. Un approfondito sforzo di ricerca e di analisi – relativamente libero dalle tensioni polemiche che avevano attraversato i lavori delle Commissioni del passato – che è stato possibile grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine − Guardia di finanza, carabinieri, e polizia −, dei magistrati, e degli studiosi al servizio della Commissione. E che sta consentendo agli organi inquirenti la conduzione di nuove indagini.
L’attività investigativa − di cui le informazioni contenute nella prima relazione pubblicata il 10 dicembre 2015 e nelle circa duecento pagine che formano la seconda relazione della Commissione, pubblicata il 20 dicembre 2016, costituiscono solo una parte, poiché molto del materiale prodotto è oggetto di indagini in corso − ha fatto emergere, con maggiore visibilità, problemi, opacità, contraddizioni già note ma che finora erano state collocate ai margini del focus dell’attenzione. E che il lavoro della Commissione, con le cautele critico-scientifiche necessarie, ha riportato al centro, sollevando così dubbi sia su alcuni aspetti omissivi delle indagini passate e su alcune delle verità giudiziarie accertate sia sulle testimonianze di parte brigatista, e in particolare sul cosiddetto «Memoriale Morucci».
Recenti accertamenti eseguiti con strumenti tecnici all’avanguardia hanno reso possibili nuove ricostruzioni della scena di via Fani; benché esse non possano ancora ritenersi complete, testimoniano delle incongruenze della narrazione brigatista poiché hanno evidenziato, fra l’altro, la grande capacità militare del commando in azione in via Fani, che è assai poco credibile attribuire alle Br; la probabile presenza di più brigatisti feriti, che apre la questione della «copertura medica» su cui le Br avrebbero potuto contare nelle vicinanze dell’agguato (come la casa di cura Villa Maria Pia); la partecipazione all’operazione di un numero più elevato di assalitori rispetto ai quattro indicati nel «Memoriale Morucci», oltre che di un nucleo che assicurò copertura e supporto all’operazione; e la presenza in via Fani di veicoli e soggetti su cui si sta ancora indagando.
A smentire nuovamente la coerenza del racconto brigatista è, inoltre, l’ipotesi − basata sulle indicazioni di una fonte riservata della Guardia di finanza attiva all’epoca del sequestro e di testimonianze già raccolte ma poco valorizzate, nonché su fonti giornalistiche come il noto racconto-inchiesta Christ in Plastic (1978) dello scrittore italo-americano Pietro Di Donato − della probabile presenza di un covo brigatista nell’area della Balduina, in prossimità del luogo del rapimento, in uno stabile di proprietà dello IOR abitato anche da prelati e sede di società estere, che è stato presumibilmente la prima prigione di Moro.
La complessità del caso Moro è poi stata accresciuta da un attento esame della documentazione e delle testimonianze relative a numerose piste investigative, alcune delle quali riguardano:
– il rapporto tra l’Italia e i movimenti palestinesi, il cui ruolo appare centrale sia nella segnalazione (che non ebbe seguito) fatta il 17 febbraio 1978 dal colonnello Giovannone, capo centro del Sismi a Beirut e persona considerata vicina a Moro, di un attentato terroristico che avrebbe potuto interessare l’Italia, sia quando, nel corso del sequestro, fu avviata una trattativa per la liberazione del leader democristiano incentrata sulla mediazione dell’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e del FPLP (Fronte popolare per la liberazione della Palestina), i cui vertici si mossero per la ricerca di canali presso diverse organizzazioni terroristiche mediorientali;
– il traffico d’armi tra terroristi italiani e Medio Oriente, sul quale − dalla documentazione raccolta − emerge quantomeno una minimizzazione da parte dei nostri servizi di intelligence (forse fondata sull’esigenza di proteggere la riservatezza di accordi sconosciuti all’opinione pubblica);
– il bar Olivetti − situato all’angolo tra via Fani e via Stresa, e frequentato fra gli altri da elementi della criminalità organizzata calabrese e siculo-americana, e da uomini dei servizi segreti di diversa nazionalità (anche italiana) −, che compare come il centro di un traffico di armi internazionale, scoperto a partire dalla fine di gennaio 1977 ma sulle cui attività non furono all’epoca condotti approfondimenti, e che − dopo un attento esame del fascicolo processuale messo a disposizione della Commissione dal Tribunale di Roma − emerge oggi come elemento decisivo per l’attuazione dell’operazione delle Br;
– l’attività svolta dalla scuola di lingue parigina Hypérion − riconducibile alla figura di Corrado Simioni, tra i fondatori del Superclan −, centro di collegamento tra gruppi del terrorismo internazionale, che per il magistrato Pietro Calogero, audito l’11 novembre 2015, gravitava nell’orbita della CIA;
– la grande quantità di incongruenze nell’arresto di Morucci e Faranda − avvenuto a Roma in casa di Giuliana Conforto − (fra cui la presenza, non facilmente spiegabile, di un elenco di membri e simpatizzanti delle Br); la possibilità che l’arresto sia stato politicamente negoziato; il ruolo avuto in questa circostanza da Giorgio Conforto, padre di Giuliana, agente del KGB noto ai servizi italiani, inspiegabilmente mai oggetto di indagini, e che, secondo il generale dei Carabinieri Antonio Federico Cornacchia − audito, parzialmente in forma segreta, dalla Commissione −, era anche al servizio della CIA e dei nostri Apparati di sicurezza;
– il problema di come e perché le Br − durante i cinquantacinque giorni del rapimento Moro − si siano divise fra diverse opzioni, come testimoniano i contrasti fra la «colonna romana» e la «colonna genovese»;
– il ruolo della criminalità organizzata − della ’ndrangheta, in particolare −, e il coinvolgimento della Rote Armee Fraktion nel sequestro e nella morte di Moro.
Insomma, attraverso un rigoroso lavoro investigativo la Commissione sta gettando luce su incongruenze, omissioni, zone d’ombra, relazioni politicamente fluide, strani rapporti internazionali che fanno del caso Moro, a quasi quarant’anni dalla scomparsa dello statista democristiano, un mistero ancora da sciogliere. Un intrigo che – senza nulla togliere alle responsabilità delle Br – è decifrabile solo alla luce dello scontro fra interessi e forze storiche confliggenti e delle geometrie di potere della guerra fredda. Ma il cui contorno è sfumato e sfuggente, così che permangono grandi difficoltà per chi ne ricerca il senso. Difficoltà aumentate dalle persistenti reticenze di alcuni auditi.
Istituendo la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, la politica ha deciso di non sottrarsi alla sfida di riaprire un caso che sotto il profilo giudiziario era stato chiuso, ma che nei suoi elementi storico-politici è ancora opaco. La mancanza di verità sull’avvenimento (che per le sue ripercussioni appare in prospettiva come una sorta di colpo di Stato, dato che ha cambiato la storia dell’Italia repubblicana) ha infatti per alcuni versi espropriato il Paese della propria memoria, con esiti rovinosi per le istituzioni e la politica. Che sono uscite da quella tragica vicenda indebolite, delegittimate, e piegate da forze interne ed esterne che hanno avvelenato la pubblica opinione. Pertanto, sulle relazioni della Commissione Moro, benché la conclusione della vicenda sia ancora lontana, il nostro giudizio è nel complesso positivo: certo, non sono state dissipate tutte le nubi, ma almeno sono stati fatti decisi passi avanti verso una maggiore chiarezza. Il gruppo di Sinistra Italiana esprime quindi il proprio voto favorevole alla risoluzione.
Intervento tenuto da Carlo Galli in Commissione Difesa il 25 gennaio 2017, in occasione della audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico

Dichiarazione di voto di Carlo Galli per Sinistra Italiana pronunciata in Aula il 10 gennaio 2017, in occasione della discussione sulla ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione del Montenegro firmato a Bruxelles il 19 maggio 2016.
Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del governo,
l’invito ad aderire all’Alleanza nordatlantica fatto al Montenegro – sulla base dell’articolo 10 del Trattato NATO del 1949 e formalizzato nel Protocollo di adesione firmato a Bruxelles dai 28 Paesi alleati il 19 maggio 2016 –, che noi dobbiamo ratificare o respingere, giunge in un momento particolarmente delicato delle relazioni fra la NATO e la Federazione russa. Date le gravi tensioni esistenti su più fronti – dal vicino Oriente all’Ucraina –, un ingresso del Montenegro nella NATO non produrrebbe alcun reale beneficio, in termini di sicurezza, per i Paesi alleati, ma – al contrario – condurrebbe a un inutile inasprimento dei rapporti con Mosca, che interpreterebbe la decisione come un’ulteriore manovra di accerchiamento nei suoi confronti e, contemporaneamente, potrebbe vedere minacciati i suoi consistenti interessi economici nella repubblica montenegrina.
A ciò si aggiungano le preoccupazioni derivanti dalle contestazioni interne, di cui ha riferito la stampa, contro il progetto di integrazione nelle strutture atlantiche, fortemente voluto dall’ex Primo ministro montenegrino, Milo Đukanović, e dal nuovo governo guidato dal suo successore Duško Marković. Infine, l’intera area balcanica è attraversata da una ondata di instabilità, prodotta dall’emergenza migratoria – che continua, nonostante la parziale chiusura della rotta balcanica nel marzo del 2016 – e dalla minaccia rappresentata dal radicalismo di matrice islamica.
Davanti a questi fronti di crisi (interni, regionali, internazionali) – che l’assenza di una visione politica e strategica europea aggrava enormemente – noi crediamo che l’ingresso del Montenegro nella Nato, lungi dal produrre un effetto stabilizzante, potrebbe inasprire le tensioni esistenti; e pertanto il gruppo di Sinistra Italiana esprime il proprio voto contrario.
Il suicidio delle sinistre
Intervento effettuato il 10 gennaio 2017 a Roma, presso la Fondazione Basso, in occasione della presentazione di Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne) di Sergio Cesaratto (Imprimatur 2016), e di La scomparsa della Sinistra in Europa di Aldo Barba e Massimo Pivetti (Imprimatur 2016).

//www.radioradicale.it/scheda/496988/iframe?i=3653488
Riforma costituzionale: le ragioni del no
Intervento effettuato in occasione della presentazione dell’e-book Riforma costituzionale: le ragioni del no (Laterza 2016), organizzata a Roma il 24 novembre 2016 dal Centro per la Riforma dello Stato presso la Fondazione Basso.

//www.radioradicale.it/scheda/492973/iframe?i=3639376
Io voto NO
Si tratta di un’intervista della tarda primavera del 2016, in cui si presentano in sintesi alcune delle ragioni del No al referendum costituzionale di dicembre
Dichiarazione di voto in sede di discussione della mozione Carlo Galli e altri n. 1-01193
Seduta n. 627, mercoledì 18 maggio 2016
Grazie, signora Presidente.
Noi chiediamo venga messa ai voti la premessa della nostra mozione e accettiamo tutte le riformulazioni, tranne quella relativa all’ANVUR, del punto 5, lettera a).
Poiché la premessa, su cui chiediamo il voto, è sostanzialmente l’analisi della situazione della ricerca universitaria italiana, dal nostro punto di vista, vorrei ripercorrere qui per sommi capi, nel poco spazio di tempo che mi è rimasto, quanto ho detto in modo molto più articolato lunedì pomeriggio in sede di discussione generale.
I concetti fondamentali che ho esposto in quella circostanza sono che la ricerca e l’Università presentano problemi che, in realtà, sono da interpretare come grandi questioni nazionali, non come singole emergenze. Questo è il punto fondamentale della nostra analisi. Queste grandi questioni strutturali – le elenco soltanto – sono la questione del sottofinanziamento del comparto ricerca e Università. Un sottofinanziamento che avviene in deroga rispetto alle indicazioni europee, che ha portato l’Italia a retrocedere rapidamente, per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato, agli ultimi posti tra i Paesi OCSE.
Abbiamo anche sottolineato come la protesta contro questo stato di cose avanzi da anni nel mondo accademico e della ricerca, sia del personale di ruolo – che ha sofferto di un blocco stipendiale gravissimo –, sia da parte dei precari, a cui sono ancora negati alcuni diritti sociali essenziali. Uno stato di cose, questo sottofinanziamento, che genera il fenomeno, al tempo stesso assurdo e doloroso, della cosiddetta «fuga dei cervelli».
Vi è poi la questione della discrezionalità e della logica privatistica, che sono quelle che stanno alla base della strategia del governo per risolvere, per credere di risolvere, per tentare di risolvere, le questioni della ricerca e dell’Università. Discrezionalità e logiche privatistiche che si vedono in modo chiarissimo nel caso dell’Istituto italiano di tecnologia e nel caso dei cosiddetti «professori Natta», mentre – al tempo stesso – i recenti finanziamenti dei quali tanto si è parlato da parte governativa sono, per la loro parte reale, del tutto insufficienti, mentre per la loro gran parte sono soltanto nominali o comunque sia si tratta di denari non nuovi, ma già impegnati.
Vi è poi un’ulteriore questione, la questione del reclutamento, che coinvolge tanto la fascia del precariato quanto la fascia del primo ingresso nel mondo universitario, ora organizzato in modo altamente illogico attraverso la distinzione fra ricercatori di serie a) e di serie b).
Vi è poi una questione meridionale aperta, chiarissima, che consiste nella crescente disparità fra gli atenei del sud e quelli del nord, con conseguenti migrazioni studentesche e desertificazione culturale delle aree meridionali. È una questione generata da meccanismi valutativi e premiali largamente distorti.
Infine, la questione della ricerca umanistica, complessivamente sottovalutata da un’impostazione aziendale produttivistica della politica universitaria. Tutto ciò considerato, noi evidentemente esprimiamo il parere favorevole alla nostre premesse e ovviamente anche a quel punto dei nostri impegni rispetto ai quali è stata data valutazione contraria da parte del governo e che riguarda l’ANVUR.
Discussione della mozione Carlo Galli e altri n. 1-01193 concernente interventi per il rilancio del comparto della ricerca italiana.
Seduta n. 625, lunedì 16 maggio 2016
Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo.
Ricerca e Università presentano non tanto singoli problemi da risolvere con interventi spot, quanto vere e proprie questioni complesse e interconnesse. La prima è la questione del sottofinanziamento: l’Unione europea ha elaborato dal 2001 la «Strategia di Lisbona», poi rinnovata con la «Strategia 2020», che mira ad accrescere il livello scientifico e tecnologico e a rendere l’Unione una delle aree più avanzate del pianeta, e pone come obiettivo quantitativo minimo la quota del 3 per cento del prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro per la ricerca e lo sviluppo. Gli ultimi governi italiani, disattendendo il dettato costituzionale (l’articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»), e in contraddizione con gli impegni di Lisbona, hanno progressivamente ridotto a Università ed enti di ricerca il supporto finanziario. L’analisi del bilancio dello Stato su dati della Ragioneria generale testimonia che, mentre cresce la spesa pubblica corrente, sulla ricerca si sono addensati tagli superiori a qualsiasi altro settore pubblico, con un calo totale del 20 per cento. Ora, a fronte di un costante declino dei fondi ordinari (FFO e FOE), si può osservare anche l’esiguità dei finanziamenti ai ricercatori su base competitiva: i cosiddetti PRIN sono rimasti inattivi al 2012, e i progetti FIRB sono cessati dal 2013; tali riduzioni di spesa hanno portato l’Italia a retrocedere rapidamente per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato agli ultimi posti tra i Paesi OCSE.
Il persistente trend di flessione del finanziamento pubblico alla ricerca distingue in negativo a livello internazionale il nostro Paese, il quale nel 2014 registra un totale di finanziamenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo pari all’1,28 per cento del prodotto interno lordo, a fronte di una media OCSE del 2,37 per cento. Il mondo della ricerca italiana conosce da tempo fermenti di critica a questo orientamento, manifestatisi già nella gestazione della legge n. 240 del 2010, che hanno assunto forme diverse in relazione a singole emergenze: protesta contro i tagli degli scatti stipendiali del 2011-2015, protesta contro le modalità di valutazione della qualità della ricerca VQR, sciopero alla rovescia promosso dal Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come attività lavorativa, richiesta di estensione dell’indennità di disoccupazione «Dis-coll» e delle tutele previdenziali e sanitarie anche agli assegnisti, ai dottorandi e ai titolari delle borse di studio. Per tali ragioni, insieme ad altre iniziative, è anche in atto una campagna di sensibilizzazione promossa dal mondo scientifico e accademico sullo stato allarmante in cui versa la ricerca pubblica italiana, che sopravvive e mantiene una elevata produttività internazionale nonostante la scarsità di risorse e la completa assenza di programmazione: vi è un appello, che conta oltre 45 mila adesioni, degli scienziati italiani all’Unione europea perché faccia pressione sul Governo italiano in questa direzione.
Inoltre, una riduttiva lettura della globalizzazione dell’economia legata esclusivamente all’accelerazione tecnologica ha determinato nel nostro Paese la diffusa idea che l’obiettivo dell’aumentare la competitività dei settori produttivi potesse essere raggiunto a costo zero, trasformando la ricerca di base in ricerca applicata, concentrando le risorse in pochi centri e università di eccellenza e lasciando alle altre il ruolo di teaching university; e infine prosciugando la cultura umanistica, ritenuta un onere superfluo rispetto allo sviluppo economico delle imprese private. Mentre la Strategia «Europa 2020» mira ad accrescere la competitività del Vecchio Continente investendo nel cosiddetto triangolo della conoscenza – istruzione, ricerca e innovazione – attraverso il programma «Horizon 2020», grazie al quale vengono finanziati dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 i progetti di ricerca e innovazione, la politica italiana si è prodotta in modo schizofrenico da un lato incentivando la ricerca e l’investimento in ricerca attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione, dall’altro con accresciuti controlli burocratici ministeriali, che esautorano le autonomie della ricerca e dell’Università. Insomma, un mix di concause che determinano il paradosso italiano, in virtù del quale si continua a contribuire ai fondi europei in misura nettamente maggiore rispetto all’entità dei finanziamenti, in conseguenza della carenza d’attenzione e dell’incertezza delle opportunità: si depaupera così il capitale umano e si finanziano i nostri concorrenti, trasferendo ad essi i ricercatori italiani (la cosiddetta «fuga dei cervelli») formati a nostre spese, che negli altri Paesi trovano condizioni migliori per esprimere i propri indubbi talenti. Tutto ciò determina anche una scarsa attrattività dell’Italia, che ha portato all’estero 15 mila ricercatori, creando così un vero e proprio buco generazionale, mentre i ricercatori entrati sono pochissimi: le uscite sono pari a 16,2 per cento e gli ingressi sono fermi al 3 per cento.
Un’ulteriore questione è la discrezionalità e la privatizzazione dei finanziamenti alla ricerca. La dispersione delle scarse risorse per la ricerca imporrebbe un maggior coordinamento, mentre in senso opposto procede la creazione, a fianco del CNR e delle università, dell’Istituto italiano di tecnologia, ovvero una fondazione privata finanziata direttamente del ministero dell’Economia e delle Finanze, che nel 2008 ha ricevuto in dotazione il patrimonio finanziario della Fondazione IRI, pari a circa 130 milioni di euro: un trattamento di favore che dovrebbe sollevare l’indignazione della comunità scientifica, a prescindere dal valore della ricerca effettuata dall’IIT; un’indignazione contro una linea emergenziale che con una mano toglie fondi e risorse alla ricerca e all’alta formazione pubblica, e con l’altra affida a poteri discrezionali, in assenza di qualsiasi controllo di merito e di verifiche, fondi e risorse. All’Istituto italiano di tecnologia il presidente del Consiglio dei ministri ha ufficialmente affidato la concessione del progetto definitivo dello Human Technopole, in associazione ai tre atenei milanesi e a diversi istituti di ricerca di area confindustriale, progetto per il quale verranno stanziati un miliardo e mezzo di euro in dieci anni: una scelta paradossale, se confrontata coi tagli mascherati al settore pubblico dell’università e della ricerca nella legge di stabilità 2016, che portano il definanziamento del sistema universitario a 1,1 miliardi di euro; una scelta tanto più paradossale, perché l’Istituto italiano di tecnologia, svolgendo anche attività di ricerca in proprio, non ha l’indipendenza necessaria per erogare finanziamenti ad altri: infatti, non può essere contemporaneamente un laboratorio e un’agenzia, non può essere giocatore e arbitro.
Ulteriore questione è quella dei recenti finanziamenti che il Presidente Renzi ha annunciato nei mesi scorsi, pari a 2,5 miliardi di euro, pur sapendo che non si tratta di risorse aggiuntive, ma della quota di cofinanziamento spettante al nostro Paese per la sua appartenenza e partecipazione al programma europeo «Horizon 2020». Nello stesso contesto il Premier ha confermato il varo di un programma nazionale per la ricerca 2015-2020 da 2 miliardi e mezzo di euro, importo che non sarebbe però costituito da risorse fresche, ma che corrisponderebbe a fondi contabilizzati da oggi al 2017 tra stanziamenti già presenti nel bilancio MIUR, per un importo pari a 1,9 miliardi di euro, e una quota relativa alla programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, per un importo di 500 milioni di euro. In sostanza, si tratterebbe della programmazione attuativa di risorse già disponibili, non nuove. Si deve tuttavia ammettere che non era scontato che il Fondo per lo sviluppo e la coesione fosse utilizzato prevalentemente per la ricerca e ciò va riconosciuto. Il suddetto piano del Governo per rilanciare ricerca e innovazione manca all’appello dal 30 gennaio 2014 quando il Consiglio dei ministri ha esaminato in via preliminare il testo elaborato dall’allora Ministra Carrozza e mai varato. Nonostante il tentato e continuo depistaggio cognitivo da parte del Premier, resta che il Governo, in perfetta continuità con quelli precedenti, prosegue una rotta dannosa per il Paese e ha stanziato per i prossimi due anni solo 100 milioni di euro con i quali poter assumere solo 861 ricercatori all’anno, mentre, invece, ne servirebbero almeno 2.400 all’anno per i prossimi otto anni.
Un’ulteriore questione è quella del reclutamento della docenza universitaria e dei ricercatori. È prioritario, infatti, affrontare l’attuale condizione di gravissima carenza di personale se si vuole evitare che il sistema universitario pubblico si avviti in una spirale di declino irreversibile. Il sottodimensionamento del corpo docente universitario italiano emerge evidente dal confronto europeo e peggiora ogni anno. La consistenza numerica attuale è in Italia inferiore di almeno il 25 per cento alla media dei valori di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Per l’effetto combinato della riduzione dei finanziamenti, dei blocchi del turnover e dei concorsi e dell’abbassamento dell’età di pensionamento negli ultimi sette anni si è verificato un crollo verticale del numero di docenti in servizio pari a meno 30 per cento per gli ordinari e meno 17 per cento per gli associati, superiore alla contemporanea modesta riduzione del numero degli studenti. In assenza di interventi normativi che sblocchino l’attuale limite al turnover previsto dall’attuale regime per le assunzioni di università statali si assisterà ad una ulteriore e pesante contrazione del corpo docente che comporterà nel 2018 il dimezzamento del numero dei professori ordinari in servizio rispetto a quello del 2008. Effetti analoghi si avranno sui professori associati che verranno ridotti circa del 27 per cento. L’attuale normativa, infatti, prevede che nel 2016 risulti spendibile per il reclutamento il 60 per cento del turnover per poi passare all’80 per cento nel 2017 e soltanto a partire dal 2018 stabilizzarsi sul 100 per cento.
Sul medesimo fronte del reclutamento universitario la legge n. 240 del 2010 ha individuato un percorso per ruolo per accedere alla docenza che ha reso meno attraente per i giovani la carriera. Infatti, la legge ha previsto che il percorso duri almeno sei anni e sia destinato ad allungarsi ulteriormente cosicché l’età media di ingresso alla docenza è oggi intorno ai 37 anni. La figura del ricercatore a tempo determinato prevista dalla suddetta legge si articola nelle due distinte fattispecie, la fattispecie A e la fattispecie B, molto simili tra loro dal punto di vista qualitativo e dei compiti istituzionali e, tuttavia, profondamente diverse dal punto di vista dell’accesso alla docenza. Infatti, la stessa legge non contempla tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione i titolari di assegno di ricerca valutando come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore solo quegli assegni che sono stati conseguiti mentre vigeva l’articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti in forza della normativa attuale. E così tale esclusione degli abilitati dal novero dei possibili candidati ha già prodotto, fino ad oggi, effetti paradossali e ha costretto gli atenei a reclutare quali ricercatori di tipo B soggetti che non hanno ottenuto l’abilitazione nazionale, a scapito di altri che, invece, l’hanno ottenuta. Attualmente, la gran parte dei ricercatori italiani usufruisce di assegni di ricerca, cioè di una forma di contratto di lavoro parasubordinato, che però non dà luogo a tutele degne di questo nome, nemmeno nel caso di periodi, purtroppo sempre più frequenti, di disoccupazione. Insomma, non si vedono riconosciuta la cosiddetta DIS-COLL. Per di più, negli ultimi dieci anni i precari sono stati espulsi dagli atenei italiani per il 93 per cento.
Ulteriore questione è poi quella che possiamo definire la nuova questione meridionale. Non vi è infatti dubbio che una serie di fenomeni preoccupanti si stia concentrando maggiormente al Sud. La crisi del sistema universitario meridionale è ben fotografata dall’ultimo rapporto Svimez, da cui emerge lo strettissimo rapporto tra la drammatica condizione giovanile nel Sud e il declino degli atenei meridionali e dei sistemi regionali di diritto allo studio. Se le risorse diminuiscono, anche le opportunità formative calano. Del resto, le misure del Governo continuano a favorire una biforcazione su base territoriale del sistema universitario italiano, favorendo gli atenei del Nord.
Stando all’ultimo rapporto ANVUR, inoltre, negli ultimi dieci anni le università meridionali hanno perduto 45 mila immatricolazioni. Non lo stesso può dirsi per quelle collocate al Centro-Nord, che, dopo un’iniziale perdita, hanno ormai superato la crisi. Lo stesso rapporto evidenzia che in Italia sette diplomati su dieci proseguono gli studi immatricolandosi all’Università secondo un flusso migratorio di studenti dal Sud al Centro-Nord pari al 25 per cento. In totale, le università del Sud riescono a trattenere poco più del 60 per cento dei diplomati meridionali, mentre pochissimi studenti del Centro-Nord si immatricolano nelle università del Sud. Il suddetto fenomeno nasce da un’iniqua distribuzione delle già scarse risorse finanziarie destinate al diritto allo studio universitario; ripartizione che, essendo legata allo stato dei bilanci di queste ultime, tiene solo parzialmente conto dei potenziali beneficiari, rappresentati da quegli studenti capaci e privi di mezzi ai quali la Costituzione attribuisce il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi e che sono maggiormente presenti al Sud.
Il suddetto progressivo abbandono delle università meridionali è il risultato anche dell’adozione, in sede di valutazione della didattica e della ricerca da parte dell’ANVUR, di meccanismi premiali distorti che, dietro alla presunta oggettività dei numeri, sta portando al collasso gli atenei meridionali ritenuti meno meritevoli di altri e sta dirottando la maggior parte delle poche risorse verso il nord. Inoltre, anche i criteri di ripartizione della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario sembrano diretti contro gli atenei meridionali, perché questi, tenendo conto del rapporto fra entrate da tasse, entrate da Fondo di finanziamento ordinario e spese, risentono della minore capacità reddituale delle famiglie meridionali di pagare tasse alte e penalizzano quegli atenei che si trovano in territori più poveri. Tale situazione è generata anche dall’onere finanziario che grava sugli studenti.
In dimensione comparativa il nostro Paese, non solo destina poche risorse pubbliche al sistema universitario, ma ha anche la tassazione studentesca tra le più alte d’Europa. Dopo le nefaste riforme dei ministri Moratti e, successivamente, Gelmini e Profumo, che hanno imposto agli atenei italiani di comportarsi in termini aziendalistici, costringendoli a ridurre l’offerta formativa e le proprie strutture nei territori e ad affidarsi, per sopravvivere, a finanziatori privati, i provvedimenti dell’attuale Governo, in piena continuità con i precedenti, confermano, accentuandola, la politica di smantellamento del sistema pubblico.
Al fine di accrescere l’attrattività a livello internazionale del sistema universitario italiano, la legge di stabilità 2013 ha istituito in via sperimentale il Fondo per le cattedre universitarie del merito «Giulio Natta», finalizzato al reclutamento straordinario in deroga alle procedure concorsuali di 500 professori ordinari e associati per chiamata diretta per elevato merito scientifico, secondo procedure nazionali ancora da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsione che introduce, di fatto, nel sistema un secondo canale di reclutamento dei docenti di natura extra concorsuale. Si tratta di una misura certamente non risolutoria dei problemi strutturali dell’università italiana, che, tra l’altro, potrebbe produrre effetti distorsivi, fra i quali un’ulteriore delegittimazione del sistema universitario.
Infine, è da sottolineare la scarsa considerazione nella quale si è tenuta la ricerca umanistica, che, nell’attuale situazione di dominanza del pensiero unico, modellato su posizioni neoliberiste, non pare adeguatamente finanziata dalla mano pubblica.
Tutto ciò premesso, la mozione di cui sono il primo firmatario impegna il Governo:
a rilanciare, con la massima urgenza, il settore della ricerca e della cultura italiana, abbandonando la logica emergenziale e discrezionale e impostando una programmazione con cadenza almeno triennale; a varare con urgenza l’annunciato programma nazionale per la ricerca 2015-2020; ad assumere iniziative per elevare, in prospettiva, l’attuale spesa per investimenti, ricerca e sviluppo a un livello pari al 3 per cento del prodotto interno lordo; ad assumere iniziative per sospendere, dal 2017, il meccanismo di contingentamento delle assunzioni, eliminando ogni limitazione del turnover; ad affrontare il problema del cofinanziamento dei fondi europei con strumenti innovativi e di sostegno che agevolino, sul piano finanziario e amministrativo, la partecipazione della ricerca italiana ai bandi comunitari; ad assumere iniziative per rivedere il sistema di valutazione della ricerca e dell’istruzione universitaria basata su fondi pubblici, affidando la valutazione ex post – ho concluso – della ricerca ad un’autorità indipendente dal MIUR, affidandole come obiettivi il miglioramento della ricerca, della didattica, dei servizi; a creare un fondo premiale per l’Università, separato dal Fondo di finanziamento ordinario, da distribuire periodicamente in ragione dei progressi realizzati da ciascun ateneo; ad assumere iniziative per fare del dottorato di ricerca un titolo preferenziale di accesso alla pubblica amministrazione; ad assumere iniziative per definire un chiaro percorso post-dottorato, non superiore a quattro anni, che recepisca quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori per un contratto unico per ruolo, con retribuzione, tutele e diritti di rappresentanza conformi a quelli dei lavoratori a tempo determinato; a individuare strategie per l’assunzione in ruolo di ricercatori a tempo determinato, sia di tipo A sia di tipo B, in possesso di abilitazione scientifica nazionale.
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza
Intervento alla Camera dei deputati in sede di dichiarazione di voto (21 aprile 2016).
Signor Presidente, onorevoli colleghi, che la Casa Museo di Antonio Gramsci in Ghilarza, dopo essere stata dichiarata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna bene di interesse culturale, storico e artistico, venga ora definita «monumento nazionale» è certamente un riconoscimento prima di tutto al lavoro volontario di quanti l’hanno fino ad ora gestita, non senza fatiche e difficoltà. Ma è soprattutto l’occasione per una breve riflessione che può essere interpretata come l’avvio delle celebrazioni, fra un anno, dell’ottantesimo anniversario della morte di Gramsci, avvenuta il 27 aprile 1937.
Che un gruppo parlamentare che si definisce di sinistra, come quello di cui io faccio parte, sia favorevole a fare della casa di Gramsci un monumento nazionale non è di per sé sorprendente. Quello che mi preme sottolineare è, piuttosto, che le motivazioni dell’assenso di Sinistra Italiana su questo provvedimento vanno oltre il patriottismo di partito e vanno oltre la pur ovvia e legittima ascrizione di Gramsci a una precisa parte politica. Qui si tratta di un monumento nazionale il cui significato vale – dovrebbe valere – per tutti.
Qual è, dunque, questo significato? Cominciamo dal capire che cosa significa la parola «monumento»: significa memoria, ricordo, e – in senso oggettivo – significa un luogo o un manufatto che reca alla memoria ciò che è degno di essere ricordato. In senso soggettivo è importante capire chi è che ricorda. In questo caso chi ricorda è la nazione, la quale ricorda un personaggio che l’ha fatta grande, non soltanto perché egli stesso è stato grande, cosa indubbiamente vera dato che Gramsci, insieme a Dante e a Machiavelli, è l’autore italiano più letto, tradotto e commentato al mondo – su di lui c’è una bibliografia, al momento, di circa 20.000 volumi –.
È stato grande non soltanto nel pensiero. È stato grande nella lotta politica condotta con coraggio personale, in condizioni non sempre facili, anche rispetto all’Unione Sovietica, all’Internazionale comunista e, a tratti, anche rispetto al suo stesso partito. Oltre, ovviamente, rispetto al fascismo che lo vide e lo considerò come l’arcinemico al cui cervello non si doveva permettere di pensare pubblicamente per almeno vent’anni. Ma è stato grande – questo è il punto – anche perché ha dato all’Italia un modo per pensare a se stessa. Perché è stato uno dei grandi mediatori dell’autocoscienza nazionale. Perché ha elaborato un’idea di Italia, un’idea non astratta ma sostenuta da una robusta e articolata cultura storico-politica che si è generata attraverso una riflessione complessa su Machiavelli, sul Risorgimento, sul Meridione, sul fascismo, sul ruolo degli intellettuali, sul partito. Una cultura non libresca ma concreta, che parla all’Italia dell’Italia. Un’idea, una cultura, che coinvolgono; davanti alle quali si deve prendere posizione; che obbligano a pensare. Un’idea fra le possibili certamente, ma che è importante per il peso specifico che ha, per la sua latitudine, per la sua capacità di abbracciarne altre, di dare rilievo ad altre.
La complessità e la grandezza di quel pensiero lo rendono e lo hanno reso conteso tra mille scuole; lo hanno esposto a mille interpretazioni; ne hanno fatto il terreno centrale di confronto e di scontro in merito al rapporto fra politica e cultura, tra teoria e prassi, fra strutture e soggettività. Attraverso Gramsci è stato affermato ora il primato della società civile, ora il primato dell’economia, ora il primato della politica, ora il primato della produzione. Non è questo il luogo, e manca il tempo, per dare anche soltanto un elenco sommario delle principali interpretazioni alle quali Gramsci è stato esposto: abbiamo avuto un Gramsci nazionaldemocratico; un Gramsci leninista; un Gramsci consiliarista; un Gramsci capace di superare il rapporto meccanico fra struttura e sovrastruttura; un Gramsci filosofo, criticato in quanto filosofo o apprezzato, al contrario, in quanto filosofo; un Gramsci gentiliano; un Gramsci liberaldemocratico post-statuale; un Gramsci mercatista; un Gramsci teorico della traducibilità delle esperienze e dei concetti da un contesto all’altro; un Gramsci talmente vivo che ancora oggi sono in corso nuove edizioni delle sue opere – edizioni anastatiche dei Quaderni e l’edizione nazionale degli Scritti –. Il suo pensiero, soprattutto oggi, è nel mondo anglofono il veicolo di una buona parte del pensiero critico, che è giunto quasi a sostituire la stessa fonte marxista nei Cultural Studies.
Gramsci è un monumento ma non una statua. Non è immobile ma è vitale. Questa contesa e questo confronto sul suo pensiero dimostrano che Gramsci non muore col Partito comunista italiano, che questo ne sia stato l’erede o il traditore. Il suo pensiero ci insegna, ancora oggi, l’analisi accurata e non sbrigativa della realtà. Ci insegna soprattutto a vedere nelle strutture sociali e nelle forme di vita, nei processi materiali e culturali, il segno del potere, dei dislivelli di potere; a vedervi le contraddizioni storiche reali che innervano la nostra società, le grandi tendenze della storia. Ci insegna la serietà e la grandezza della politica. Il pensiero di Gramsci è, insomma, un organismo ancora vivente, grazie proprio al suo spessore e alla sua complessità.
Ogni tempo ha il suo Gramsci o può averlo se si impegna a pensare la politica in modo coerente. Il pensiero di Gramsci non è necessariamente uno strumento di analisi, ma è, in senso lato, un esempio – uno fra i possibili – di coscienza critica, di alta valutazione della politica, di esercizio impegnato di questa. Il che fa di Gramsci un maestro etico, politico e intellettuale.
Insomma, non vi è alcun bisogno di essere gramsciani in senso ideologico per trovare giusto e ragionevole questo provvedimento di legge che fa della Casa Museo di Ghilarza un monumento nazionale, perché è giusto e ragionevole – direi necessario – che una nazione rifletta su se stessa attraverso la riflessione sui suoi grandi uomini. È giusto e necessario che una nazione si ricordi di se stessa, che faccia memoria di se stessa, ed è giusto che la politica, cioè questa Camera, sia promotrice di questa riflessione e sia promotrice anche di una politica che – anche se non è, come voleva Gramsci, la sostanza della filosofia e della storia –, si sforzi tuttavia di nutrirsi profondamente e sistematicamente di cultura, e di essere quindi qualcosa di più che non un disinvolto pragmatismo condito da molta narrazione e da qualche generico riferimento a «valori».
Mozione 1-01193
Seduta del 2 maggio 2016. Si pubblica il testo riformulato della mozione Galli Carlo n. 1-01193, già pubblicata nell’allegato B ai resoconti della seduta n. 586 del 9 marzo 2016.
La Camera,
premesso che:
il grado di civiltà e di democrazia di una nazione si misura anche dal grado di diffusione delle conoscenze scientifiche e più in generale dalla consapevolezza culturale dei suoi cittadini e tali principi sono sanciti dall’articolo 9 della Costituzione secondo il quale: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica »;
le sfide poste dalla globalizzazione, dalla rivoluzione delle comunicazioni e dell’informatica e dal passaggio alla «società della conoscenza», rendono necessario adeguare le forme sin qui invalse nell’accesso al sapere e nel sostegno alla ricerca, in relazione sia alla crescente importanza delle conoscenze nella competitività internazionale, sia alla esigenza di confrontarsi con altre lingue e culture;
l’Unione europea ha elaborato dal 2001 una apposita «strategia di Lisbona», rinnovata con la Strategia 2020, che mira ad accrescere il livello scientifico e tecnologico e a rendere l’Unione una delle aree più avanzate del pianeta e pone come obiettivo quantitativo minimo la quota del 3 per cento del prodotto interno lordo per ricerca e sviluppo;
spetta agli Stati membri dell’Unione europea assicurare un armonioso sviluppo di ricerca e cultura, il cui snodo istituzionale è l’università pubblica, garantendone una idonea distribuzione territoriale per assicurare pari opportunità e coesione sociale;
davanti alle sfide aperte dalla trasformazione delle società industriali e dalle esigenze di maggiore formazione e qualificazione dei cittadini e della forza lavoro, gli ultimi Governi italiani, disattendendo il dettato costituzionale e in contraddizione con gli impegni di Lisbona, hanno progressivamente ridotto ad università ed enti di ricerca il supporto finanziario necessario al loro funzionamento, al punto da metterne a volte a repentaglio la sopravvivenza;
l’analisi del bilancio dello Stato su dati della ragioneria generale testimonia come, mentre cresce la spesa pubblica corrente, sulla ricerca si siano addensati tagli superiori a qualsiasi altro settore pubblico: la missione 17 (ricerca e innovazione) dal 2008 al 2014 è passata da 4 miliardi di euro a 2,8 miliardi di euro e la missione 23 (istruzione universitaria) nel medesimo arco temporale è passata da 8,6 miliardi di euro a 7,8 miliardi di euro, con un calo totale del 20 per cento. Come dichiarato nel corso di un’audizione al Senato dalla ragioneria dello Stato tra le complessive 34 missioni che costituiscono il bilancio statale quelle maggiormente ridimensionate (nel suddetto periodo) sono state, nell’ordine, la missione, Istruzione universitaria (-19,9 per cento in media), la missione fondi da ripartire (-14,5 per cento in media) e la missione ricerca e innovazione (-12,17 per cento in media);
la struttura dei finanziamenti pubblici alla ricerca, stanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca quale organo istituzionalmente deputato, è riconducibile a due tipi di fondi: il fondo ordinario all’università (FFO), che dovrebbe coprire la spesa per gli stipendi del personale docente e amministrativo, per la ricerca e per la manutenzione delle strutture; il fondo ordinario agli enti (FOE), a cui si aggiungono i finanziamenti competitivi (PRIN) e (FIRB) a università ed enti e di finanziamenti alla ricerca industriale (FAR). L’analisi dei dati relativi restituisce una immagine disastrosa: a fronte di un costante declino dei fondi ordinari, si può osservare anche l’esiguità dei finanziamenti ai ricercatori su base competitiva, essenziali per selezionare nel Paese quei gruppi che, svolgendo ricerca ai livelli più alti, potranno confrontarsi a livello internazionale. I cosiddetti PRIN (progetti di ricerca di interesse nazionale) sono rimasti inattivi dal 2012. Istituiti nel 1996 dal Governo Prodi, rappresentavano allora il principale supporto per la ricerca pubblica: da un budget di 137 milioni di euro destinati nel 2003 alle 14 aree di ricerca, si era passati, complice la spending review, ad appena 92 milioni di euro, da destinare a tutte le aree di ricerca. I progetti FIRB per i giovani ricercatori, partiti nel 2004 con 155 milioni di euro, sono andati estinguendosi progressivamente fino a cessare dal 2013. Tali riduzioni di spesa hanno portato l’Italia a retrocedere rapidamente, per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato agli ultimi posti fra i Paesi OCSE;
il persistente trend di flessione del finanziamento pubblico alla ricerca distingue in negativo a livello internazionale il nostro Paese, il quale nel 2014 registra un totale di finanziamenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo pari all’1,28 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media OCSE del 2,37 per cento. Questi scarsi fondi sono ripartiti per circa lo 0,70 per cento alla ricerca industriale, e circa lo 0,16 per cento ad enti pubblici, mentre nel 2014 i finanziamenti pubblici all’università erano pari allo 0,42 per cento contro lo 0,99 per cento della Francia, lo 0,98 per cento della Germania e lo 0,73 per cento della Spagna;
il trend italiano mostra un Paese inginocchiato da una crisi frutto anche di mancate scelte di investimento nella conoscenza, nell’innovazione tecnologica e nei settori industriali a più alto valore aggiunto, ed evoca lo spettro di una strisciante desertificazione culturale, scientifica e tecnologica, già occorsa in alcune aree del Paese. Dati di questi giorni della Banca d’Italia parlano di un prodotto interno lordo pro-capite del Mezzogiorno pari alla metà di quello del Nord, mentre procede un esodo di studenti dal Sud al resto del Paese che getta le basi per la genesi di una nuova «questione meridionale»;
il mondo della ricerca italiana conosce da tempo fermenti di critica a questo orientamento, manifestatisi già nella gestazione della legge n. 240 del dicembre 2010 e che hanno assunto forme diverse in relazione a singole emergenze – dalla protesta contro i tagli e gli scatti stipendiali del 2011-2015 che discriminano i professori e ricercatori di ruolo delle università, alle modalità di valutazione della qualità della ricerca (VQR), allo sciopero alla rovescia promosso dal Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come attività lavorativa, o alla richiesta di estensione dell’indennità di disoccupazione «DIS-COLL» e delle tutele previdenziali e sanitarie anche agli assegnisti, ai dottorandi e ai titolari di borse di studio – istanze comunque tutte riconducibili all’assenza di prospettive nella ricerca e nella cultura per le giovani generazioni;
per tali ragioni, assieme ad altre iniziative, è in atto una campagna di sensibilizzazione promossa dal mondo scientifico ed accademico sullo stato allarmante in cui versa la ricerca pubblica italiana che, nell’indifferenza generale, sopravvive e mantiene una elevata produttività internazionale, nonostante la scarsità di risorse e la completa assenza di programmazione. Con il loro accorato appello, che conta oltre 45.000 adesioni, gli scienziati italiani invitano l’Unione europea a fare pressione sul Governo italiano affinché finanzi adeguatamente la ricerca portando i relativi fondi ad un livello sensibilmente superiore e congruo con la media europea del 2,2 per cento del prodotto interno lordo;
invero, una riduttiva lettura della globalizzazione dell’economia e dell’impetuoso sviluppo di Paesi come l’India e la Cina, legata esclusivamente all’accelerazione tecnologica, ha trascurato i nodi strutturali e determinato nel nostro Paese la diffusa idea che l’obiettivo imprescindibile di aumentare la competitività dei settori produttivi potesse essere raggiunto a costo zero attraverso una scorciatoia burocratica: trasformando la ricerca di base in ricerca applicata, concentrando le risorse in pochi centri ed università di eccellenza, lasciando alle altre il ruolo di teaching university, ed infine prosciugando la cultura umanistica, ritenuta un onere superfluo allo sviluppo economico delle imprese private. In tale accezione, la ricerca pubblica rappresenterebbe soltanto uno strumento per accrescere la competitività economica delle aziende esistenti, dimenticando che la ricerca è chiamata ad assurgere al ruolo di propulsore della crescita civile oltre che economica di lungo periodo. Peraltro, elevare il livello culturale complessivo del Paese è un’esigenza segnalata dalla stessa teoria dello sviluppo economico che insiste sul nesso tra gli investimenti in ricerca e innovazione e la complessiva coesione culturale come premessa alla sua capacità di accrescere il livello di benessere nel tempo;
non a caso la strategia «Europa 2020» mira ad accrescere la competitività globale del Vecchio continente investendo nel cosiddetto «triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione), attraverso il programma «Horizon 2020» grazie al quale vengono finanziati dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, i progetti di ricerca ed innovazione di università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese e aziende attive soprattutto nel settore tecnologico. Il Consiglio europeo, già nel marzo del 2005 rilevando il ritardo della strategia di Lisbona, aveva sottolineato, oltre l’obiettivo generale del 3 per cento, l’obiettivo complementare di modificare il rapporto tra le fonti di finanziamento, facendo sostenere al settore privato almeno i due terzi della spesa per la ricerca e sviluppo da parte di imprese e settore privato non profit;
invece di cogliere quell’opportunità per collegare imprese e ricerca con lo straordinario patrimonio culturale, e partecipare in modo non subalterno ai programmi europei, la politica italiana si è prodotta in schizofreniche disposizioni: da un lato quelle incentivanti, come il riconoscimento di un credito d’imposta per investimenti in ricerca ed innovazione; dall’altro, un accresciuto controllo burocratico ministeriale che esautora le autonomie della ricerca e dell’università, inibisce l’operatività dei programmi comunitari e blocca l’avvio dei bandi pubblici. Insomma, un mix di concause che determinano il «paradosso italiano», in virtù del quale si continua a contribuire ai fondi europei in misura nettamente maggiore rispetto all’entità dei finanziamenti che, con l’esiguo numero dei ricercatori, si riesce a catturare con progetti di ricerca. In conseguenza della carenza di attenzione e dell’incertezza delle opportunità e dei finanziamenti si depaupera il capitale umano e si finanziano i nostri concorrenti col trasferimento di ricercatori italiani (cosiddetta «fuga di cervelli»), formati a nostre spese, che negli altri Paesi trovano condizioni migliori per esprimere i propri talenti;
la scarsa attrattività dell’Italia ha portato all’estero circa 15.000 ricercatori, creando un vero e proprio buco generazionale e facendo perdere competitività al nostro Paese rispetto agli altri Stati membri: un regalo di intelligenze non compensato da contestuali ingressi dall’estero. Secondo recenti rilevazioni, infatti, le uscite sono pari al 16,2 per cento mentre gli ingressi dall’estero sono fermi al 3 per cento. Nel 2013 operava in Italia un numero di ricercatori pubblici e privati pari a 164 mila unità (4,9 ogni 1.000 occupati), mentre negli altri maggiori Paesi europei, la presenza di ricercatori è più numerosa e capillare: 357 mila in Francia (9,8 ricercatori per 1.000 occupati); 522 mila in Germania (8,5); 442 mila nel Regno Unito (8,7); 216 mila in Spagna (6,9);
la dispersione delle scarse risorse per la ricerca tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e altri Ministeri quali politiche agricole alimentari e forestali, salute, difesa, sviluppo economico e ambiente e tutela del territorio e del mare, imporrebbe un maggior coordinamento, mentre in senso opposto procede la creazione, a fianco del CNR e delle università, dell’IIT, ovvero una fondazione privata finanziata direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, che nel 2008 ha ricevuto in dotazione il patrimonio finanziario della fondazione IRI pari a circa 130 milioni di euro, cioè risorse pubbliche provenienti dalle spoglie della più grande holding industriale pubblica del Paese: un trattamento di favore che dovrebbe sollevare l’indignazione della comunità scientifica contro una linea emergenziale che con una mano toglie fondi e risorse alla ricerca ed all’alta formazione pubblica e, dall’altra, le affida a poteri discrezionali, in assenza di qualsiasi controllo di merito e di verifiche;
all’IIT il Presidente del Consiglio dei ministri ha ufficialmente affidato la concessione del progetto definitivo dello Human Technopole, in associazione ai tre atenei milanesi ed a diversi istituti di ricerca di area confindustriale, progetto per il quale verranno stanziati 1,5 miliardi di euro in dieci anni. Una scelta paradossale se confrontata coi tagli mascherati al settore pubblico dell’università e della ricerca nella legge di stabilità per il 2016 che portano il definanziamento del sistema universitario a quota 1,1 miliardi di euro;
lo stesso Presidente Renzi ha annunciato nei mesi scorsi lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro per la ricerca pur sapendo che non si tratta di risorse aggiuntive ma della quota di cofinanziamento spettante al nostro Paese per la sua appartenenza al programma europeo «Horizon 2020». Nello stesso contesto il Premier ha confermato il varo di un programma nazionale per la ricerca 2015- 2020 da 2,5 miliardi di euro, importo che non sarebbe però costituito da risorse «fresche» ma che corrisponderebbe a fondi contabilizzati da oggi al 2017, tra stanziamenti già presenti nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per un importo pari a 1,9 miliardi di euro e una quota relativa alla programmazione nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020 per un importo di 500 milioni di euro: in sostanza si tratterebbe della programmazione attuativa di risorse già disponibili;
il suddetto piano del Governo per rilanciare ricerca ed innovazione manca all’appello dal 30 gennaio 2014 quando il Consiglio dei ministri esaminava in via preliminare il teste elaborato dall’allora Ministra Maria Chiara Carrozza e mai varato. Nonostante quello che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano il tentato e continuo «depistaggio cognitivo» da parte del Premier resta un’amara realtà: il Governo in perfetta continuità con quelli precedenti prosegue una rotta catastrofica per il Paese ed ha stanziato per i prossimi due anni solo 100 milioni di euro con i quali poter assumere solo 861 ricercatori all’anno, mentre, invece, ne servirebbero almeno 2.400 all’anno per i prossimi otto;
l’istruzione universitaria è un investimento pubblico che si ripaga nel medio periodo: per i giovani che la frequentano per il quali, oltre all’acquisizione di conoscenze e competenze, che consentono di svolgere attività maggiormente retribuite, essa rappresenta il principale fattore di mobilità sociale se si pensa che nel nostro Paese oltre il 70 per cento degli studenti universitari appartiene a famiglie in cui nessuno dei genitori è in possesso di una laurea; per le imprese, perché disporre di una forza lavoro con elevato grado di istruzione aumenta la competitività e rende possibile un maggiore tasso d’innovazione;
dunque anche le politiche di reclutamento del personale universitario sono da ripensare. È oltremodo prioritario e doveroso affrontare l’attuale condizione di gravissima carenza di personale se si vuole evitare che il sistema universitario pubblico si avviti in una spirale di declino irreversibile, sottraendo all’Italia quegli strumenti indispensabili di innovazione e crescita culturale, economica e sociale di cui le università da sempre sono centri insostituibili di sviluppo e disseminazione;
il sottodimensionamento del corpo docente universitario italiano, e più in generale del complesso degli addetti alla ricerca universitaria, emerge evidente dal confronto europeo, e peggiora ogni anno di più. La consistenza numerica attuale è in Italia inferiore di almeno il 25 per cento alla media dei valori di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, solo per limitarsi ai Paesi più simili al nostro per dimensioni e tradizioni;
per l’effetto combinato della riduzione dei finanziamenti, dei blocchi del turnover e dei concorsi, e dell’abbassamento dell’età di pensionamento, negli ultimi sette anni si è verificato un crollo verticale del numero di docenti in servizio, pari a meno 30 per cento per gli ordinari, e meno 17 per cento per gli associati, superiore alla contemporanea modesta riduzione del numero degli studenti. A questo si aggiungano gli effetti derivanti dal graduale esaurimento della cosiddetta terza fascia prevista dalla normativa vigente;
numerose analisi dimostrano che in assenza di interventi normativi che sblocchino l’attuale limite al turnover previsto dall’attuale regime per le assunzioni delle università statali, si assisterà da un’ulteriore pesante contrazione del corpo docente che comporterà nel 2018 il dimezzamento del numero dei professori ordinari in servizio, rispetto a quello del 2008. Effetti analoghi si avranno sempre nel 2018, nell’ipotesi in cui nel frattempo non si proceda ad alcuna nuova assunzione o promozione dei professori associati, con una sensibile riduzione degli stessi pari al 27 per cento rispetto a quelli in servizio nel 2008. L’attuale normativa, infatti, prevede che nel 2016 risulti spendibile per il reclutamento il 60 per cento del turnover, per poi passare all’80 per cento nel 2017 e solo a partire dal 2018 a stabilizzarsi al 100 per cento;
altrettanto improponibile è la persistente chiusura del sistema universitario ai giovani ricercatori, aggravata ancora una volta da interventi normativi (come la suddetta messa ad esaurimento della fascia dei ricercatori) che, sconvolgendo il regime ordinario di carriera nell’organico docente, per di più in un contesto di carenza di risorse, hanno innescato incertezze e meccanismi di instabilità esiziali per l’ordinaria attività didattica e di ricerca;
di più. Sul medesimo fronte del reclutamento universitario la legge 30 dicembre 2010, n. 240, (riforma del sistema universitario), nell’individuare un percorso pre-ruolo per accedere alla docenza, ha reso meno attraente per i giovani la carriera. La stessa legge, infatti, ha previsto che il percorso che deve affrontare un ricercatore universitario e che porta alla stabilizzazione della posizione professionale duri almeno sei anni, percorso destinato ad allungarsi ulteriormente e che può portare l’età media di ingresso alla docenza a 37 anni, se invece si guarda alle variegate di figure di accesso (assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B, borse post-doc);
la figura del ricercatore a tempo determinato (cosiddetta RTD), nelle previsioni della suddetta legge n. 240 del 2010, si articola nelle due distinte fattispecie: quella del RTD-a e quella del RTD-b, molto simili tra loro dal punto di vista qualitativo e dei compiti istituzionali, essendo prevista per entrambi l’attività di ricerca e quella didattica e quindi distinti solo per aspetti quantitativi nel rapporto tra questi impegni, ma profondamente diversi dal punto di vista dell’accesso alla docenza dal momento che i ricercatori appartenenti alla categoria B, a seguito di valutazione positiva dopo un triennio, possono transitare nel ruolo di professore associato, mentre per quelli appartenenti alla categoria A, la stessa valutazione positiva dopo il triennio dà loro solo il diritto di vedersi riconosciuta la proroga biennale dell’incarico e a poter aspirare al ruolo solo in presenza di un concorso disponibile;
inoltre, la stessa legge, laddove disciplina la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, tutti i titolari di assegni di ricerca, valutando come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore solo quegli assegni conseguiti nel vigore dell’articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti in forza della normativa attuale. Ed invero tale esclusione degli abilitati dal novero dei possibili candidati ha già prodotto fino ad oggi effetti paradossali, avendo costretto gli atenei a reclutare quali ricercatori di tipo B soggetti che non hanno ottenuto l’abilitazione nazionale, pur avendo partecipato alla procedura, a scapito di altri che invece l’hanno ottenuta, guadagnandosi il diritto a partecipare a concorsi per posizioni di seconda fascia, ma, paradossalmente, non a quelli per posti di ricercatore di tipo B. L’esclusione dei candidati abilitati, peraltro discriminatoria e contraria alla promozione del merito, ha aumentato il rischio per gli atenei di investire a vuoto su parte di essi essendo i primi, al termine del percorso triennale, destinati a fuoriuscire dal sistema;
eppure la condizione del ricercatore a tempo determinato, oltre ad essere centrale nel meccanismo di reclutamento universitario, vista la sua funzione di traghettamento verso posizioni a tempo indeterminato, assolve, allo stesso tempo, seppur in modo disordinato ed improprio, il compito di supporto formale alla permanenza nei dipartimenti per tanti giovani attivi ed interessati alla ricerca, sempre più spesso diretti responsabili del funzionamento di corsi di laurea e di dottorato;
attualmente, la gran parte dei ricercatori italiani usufruisce di assegni di ricerca, cioè di una forma di contratto di lavoro parasubordinato che però non dà luogo a tutele degne di questo nome, nemmeno nel caso di periodi purtroppo, sempre più frequenti, di disoccupazione. Essi non si vedono, infatti, riconosciuta la «DIS-COLL» e ciò rende evidente quanto siano necessarie spinte «esterne», affinché all’attività di ricerca dei precari possa essere attribuito un degno riconoscimento, come nel resto d’Europa. Lasciando pertanto fuori dal sistema di protezione sociale decine di migliaia di persone già sottoposte a condizioni contrattuali ed economiche di precarietà e che, nonostante questo, contribuiscono con passione alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, offrendo un lavoro invisibile che si cela dietro il progredire della conoscenza: insomma, una generosità, quella dei precari, non ripagata visto che negli ultimi dieci anni più del 93 per cento di essi è stato espulso dagli atenei italiani;
se è vero che il declino dell’università è una questione nazionale, non vi è dubbio, che una serie di fenomeni preoccupanti si stia concentrando maggiormente al Sud, acuendo quel gap economico e sociale creatosi storicamente nel Paese e meglio noto come «questione meridionale» e determinandone una tutta nuova all’interno dell’università italiana;
la crisi del sistema universitario meridionale è ben fotografata dall’ultimo Rapporto Svimez, da cui emerge lo strettissimo rapporto tra la drammatica condizione giovanile nel Sud ed il declino dei suoi atenei e del sistema regionale di diritto allo studio. Se le risorse diminuiscono, anche le opportunità formative calano, escludendo inevitabilmente un’intera generazione dallo studio e quindi dalle prospettive di lavoro. Del resto le misure del Governo continuano a favorire una biforcazione su base territoriale del sistema universitario italiano, a parità di risorse, favorendo gli atenei del Nord, prova ne è l’investimento sullo Human Technopole, che produrrà un fortissimo effetto attrattivo di ricercatori verso l’area milanese;
inoltre, stando all’ultimo rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario, negli ultimi dieci anni, le università meridionali hanno perso 45.000 immatricolazioni; non lo stesso può dirsi per quelle collocate al Centro-nord, che dopo un’iniziale perdita, hanno superato la crisi. Lo stesso rapporto evidenzia che in Italia, 7 diplomati su 10 proseguono gli studi immatricolandosi all’università, secondo un flusso migratorio di studenti dal Sud al Centro-nord pari al 25 per cento. In totale, quindi, le università del Sud riescono a «trattenere» poco più del 60 per cento dei diplomati meridionali, mentre pochissimi studenti del Centro-nord si immatricolano nelle università del Sud. Il sistema universitario del Centro-nord, invece, oltre ai diplomati locali riesce ad attrarre altri 2 diplomati su 10 provenienti dal Sud;
il suddetto fenomeno non può essere semplicisticamente motivato dall’attrazione esercitata dalle grandi università o dalle città del Nord, quanto, piuttosto, da un’iniqua distribuzione delle già scarse risorse finanziarie destinate al diritto allo studio universitario e messe in campo dalle regioni, ripartizione che, essendo paradossalmente legata allo stato dei bilanci di queste ultime, tiene solo parzialmente conto dei potenziali beneficiari, rappresentati da quegli studenti capaci e privi di mezzi ai quali la Costituzione italiana attribuisce il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi, e che sono maggiormente presenti al Sud;
il suddetto progressivo abbandono delle università meridionali è il risultato anche dell’adozione, in sede di valutazione della didattica e della ricerca da parte dell’ANVUR di meccanismi premiali distorti e che dietro alla presunta oggettività dei numeri, sta portando al collasso gli atenei meridionali ritenuti meno meritevoli di altri, dirottando la maggior parte delle poche risorse, insufficienti al finanziamento del sistema, verso il Nord. Inoltre, anche i criteri di ripartizione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario sono diventati una clava contro gli atenei meridionali, perché questi – tenendo conto del rapporto fra entrate da tasse, entrate da Fondo di finanziamento ordinario e spese – risentono della minore capacità reddituale delle famiglie di pagare tasse alte, e penalizzano quegli atenei che si trovano in territori più poveri;
tale situazione è anche generata dall’onere finanziario che grava sugli studenti. In dimensione comparativa, il nostro Paese non solo destina poche risorse pubbliche al sistema universitario, ma ha anche la tassazione studentesca tra le più alte d’Europa. Inoltre, anche il sistema di attribuzione delle borse di studio, affidato alle regioni attraverso un meccanismo redistributivo, di fatto pone il finanziamento a carico degli stessi studenti universitari;
in termini sociali chi patisce di più il fortissimo aumento delle tasse universitarie e l’inconsistenza del diritto allo studio sono le famiglie più povere, con un effetto negativo sulla dinamica della diseguaglianza nel nostro Paese;
dopo le nefaste riforme dei Ministri Moratti, e successivamente, Gelmini e Profumo che hanno imposto agli atenei italiani di ragionare in termini aziendalistici costringendoli a ridurre l’offerta formativa e le proprie strutture nei territori e ad affidarsi, per sopravvivere, alle mani di finanziatori privati, i provvedimenti dell’attuale Governo, in piena continuità con i precedenti, confermano, accentuandola, la politica di smantellamento del sistema universitario pubblico, il solo capace di garantire uguali opportunità formative, in favore di poche istituzioni universitarie di eccellenza, finendo con il determinare un’odiosa discriminazione tra studenti che hanno la possibilità economica di studiare nelle sedi più prestigiose e chi, anche se più meritevole, invece non ce l’ha;
al fine di accrescere l’attrattività a livello internazionale del sistema universitario italiano, la legge di stabilità per il 2016 ha istituito in via sperimentale il «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta » finalizzato al reclutamento straordinario, in deroga alle procedure di cui alla legge n. 240 del 2010, di 500 professori ordinari e associati per chiamata diretta per elevato merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsione che, perpetuando la possibilità di far salire in cattedra i titolari di quelle vecchie abilitazioni che secondo le previsioni originarie avrebbero dovuto avere una validità limitata a tre anni, introduce, di fatto, nel sistema un secondo canale di reclutamento dei docenti di natura extraconcorsuale. Insomma, si tratta, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, di una sorta di «pannicello caldo» presentato dal Governo come una misura risolutoria ai problemi strutturali della scienza e dell’università italiana, che potrebbe, fra l’altro, produrre effetti distorsivi tra i quali una ulteriore delegittimazione del sistema universitario, la creazione di disparità inaccettabili tra individui con professionalità comparabili, la marginalità dei possibili effetti sistemici unita al rafforzamento di alcune sedi universitarie di eccellenza ed individuate in base alle libere scelte dei vincitori;
anche in ambito universitario si assiste, oramai da alcuni decenni, al disinvestimento che sta subendo quel settore della formazione e della ricerca italiana e che sinora ha rappresentato l’asse portante dell’identità culturale della nazione, e cioè quello degli studi umanistici, deperimento che, in una fase storica in cui il sistema economico-finanziario fa da traino indisturbato alle scelte politiche e sociali, è supportato da un «pensiero unico» tecnico-nazionale e materialista modellato su posizioni neoliberiste e secondo il quale ogni conoscenza dev’essere finalizzata ad una prestazione e tutto dev’essere orientato all’utile: una pericolosa deriva che, attraverso una continua delegittimazione del ruolo civile dell’insegnamento umanistico, porta al graduale impoverimento della capacità critica delle coscienze;
in un mondo dominato oramai dall’economia della conoscenza, la ricerca insieme all’istruzione sono i pilastri su cui si costruisce il futuro e la prosperità, pertanto un Paese che non investe in ricerca, sviluppo e cultura è condannato a non avere futuro,
impegna il Governo:
a rilanciare, con la massima urgenza, il settore della ricerca e della cultura italiana, abbandonando definitivamente la logica emergenziale e discrezionale con cui si è proceduto negli ultimi anni e impostando una programmazione lungimirante con cadenza almeno triennale che dia stabilità e prospettive alla ricerca ed all’università;
a varare con urgenza l’annunciato programma nazionale per la ricerca 2015- 2020 e ad assumere iniziative per elevare, in prospettiva, l’attuale spesa per investimenti in ricerca e sviluppo ad un livello pari al 3 per cento del prodotto interno lordo, anche al fine di accrescere i livelli di occupazione e benessere sociale del nostro Paese, e per adeguare nell’immediato i finanziamenti al sistema pubblico di formazione e ricerca alla media dei Paesi OCSE, del 2,2 per cento, ripristinando i fondi PRIN (progetti di rilevante interesse nazionale) e FIRB (fondo per gli investimenti della ricerca di base);
ad assumere iniziative per sospendere dal 2017 il meccanismo di contingentamento delle assunzioni, eliminando dalla normativa ogni limitazione del turnover, al fine di assicurare il ricambio generazionale per tutte le figure del mondo universitario e della ricerca pubblica;
ad affrontare il problema del co-finanziamento dei fondi europei con strumenti innovativi di sostegno che agevolino sul piano finanziario e amministrativo la partecipazione della ricerca italiana ai bandi su fondi comunitari;
ad assumere iniziative per rivedere il sistema di valutazione della ricerca e dell’istruzione universitaria nazionale basata su fondi pubblici:
a) affidando la valutazione ex post della ricerca ad un’autorità indipendente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eventualmente modificando le attuali strutture e funzioni dell’ANVUR e affidandole come obiettivi oltre a quello del miglioramento della ricerca e, con riferimento al sistema universitario, quello della didattica e dei servizi, anche l’individuazione di punti di forza e debolezze della complessa stratificazione della geografia accademica italiana;
b) creando un fondo premiale per le università, separato dal Fondo di finanziamento ordinario, da distribuire periodicamente in ragione dei progressi realizzati da ciascun ateneo nella ricerca e nei servizi, oltre che nella correttezza della gestione economica, e definendo i criteri in virtù della collocazione territoriale, anche rivedendo gli attuali criteri di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario per giungere a degli indicatori stabili e noti ex ante, sottoposti al vaglio rigoroso della comunità scientifica attraverso il Consiglio universitario nazionale;
ad assumere iniziative per fare del dottorato di ricerca un titolo preferenziale di accesso alla pubblica amministrazione e agli enti locali, in modo da accrescere il livello della competenza tecnica nello Stato, nelle regioni e negli enti locali, e creare circuiti virtuosi di competenza;
ad assumere iniziative per definire un chiaro percorso post-dottorato, non superiore a quattro anni, che recepisca quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori, con un contratto unico pre- ruolo, con retribuzione, tutele e diritti di rappresentanza conformi a quelle dei lavoratori a tempo determinato;
ad individuare strategie per l’assunzione in ruolo di ricercatori a tempo determinato sia di tipo A che di tipo B in possesso di abilitazione scientifica nazionale.
(1-01193) «Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Ricciatti, Gregori, Ferrara, Martelli, Scotto».
L’Europa nel disordine globale
Relazione tenuta il 19 febbraio 2016 in apertura dell’evento romano con il quale la nascente Sinistra Italiana si è presentata al Paese
L’Europa e la guerra globale
Intervento alla Camera dei deputati, 16 dicembre 2015
Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signori membri del governo, la crisi che il Consiglio europeo si sforzerà di fronteggiare domani e dopodomani è senza dubbio di straordinaria complessità: si sviluppa su quattro fronti, ciascuno dei quali complesso al suo interno, e ciascuno dei quali connesso agli altri.
Il primo è il fronte del vicino Oriente segnato da una guerra ibrida, sia spaziale sia terroristica, asimmetrica, dentro la quale stanno, a loro volta, molte guerre: la guerra civile interislamica fra sciiti e sunniti; il crollo dell’ordine geopolitico della pace di Sèvres; la politica di potenza di alcuni importanti Paesi dell’area, e anche della Russia − che genera infinite doppiezze e connivenze −; la guerra di sterminio delle minoranze non islamiche condotta da Daesh; il collasso della Siria come compagine statale; il rischio di ancora maggiore diffusione dell’area di influenza di Daesh nel Nord Africa, e segnatamente in Libia. Che fra le origini di questa catastrofe ci sia quella che Obama definì nel 2002 «la guerra imbecille» di Bush contro l’Iraq è fuori di dubbio: i bombardamenti − ma di chi, contro chi, a quale fine ? − non sono la soluzione di quella guerra, ma la sua origine.
Il secondo fronte è in Europa, alle sue frontiere, dove si ammassano centinaia di migliaia di profughi disperati che fuggono dagli orrori dei molti conflitti in atto e che è difficile trattare, tanto secondo regole datate e inique quanto secondo nuovi accordi di distribuzione che non vengono, di fatto, rispettati dagli Stati europei − chiusi nelle loro paure e nei loro egoismi, e tentati di offrire soluzioni soltanto burocratiche e restrittive −.
Il terzo fronte è nelle banlieue, nelle periferie, dove europei che sono la seconda e la terza generazione di immigrati manifestano la loro rabbia per l’esclusione sociale e sistematica che subiscono. Se gli esecrabili fatti di terrorismo che hanno colpito Parigi sono atti strategici, cioè parte di una guerra guerreggiata, è anche vero che sono fenomeni endemici ripetibili, che hanno una radice non solo nelle insufficienze pur gravi di questa o di quella politica, ma nell’intero nostro modello economico in crisi, che ormai ha ben poco da offrire, soprattutto alle fasce sociali più deboli.
Il quarto fronte è dentro i ceti politici europei tentati di rispondere a queste crisi con riflessi identitari a volte grotteschi, con strumentalizzazioni incoscienti, con la rinuncia securitaria a molti livelli di garanzia dei diritti, con un impoverimento complessivo della democrazia, col blocco della dinamica politica allo scopo di tutelare una democrazia sempre più debole davanti a montanti forze antidemocratiche, come il caso recentissimo della Francia. Tentati, insomma, di lucrare sul sommarsi della crisi sociale e della crisi di sicurezza, e di sostenere che è l’Islam a radicalizzarsi mentre evidentemente sono in Europa i radicali ad islamizzarsi. Il problema è non tanto perché ci siano così tanti islamici in Europa, ma perché crescano tanti radicali nichilisti dentro i confini del Vecchio Continente, i quali poi ricodificano il loro estremismo in vesti islamiche.
Davanti a queste crisi e a questa guerra globale l’Europa balbetta, incapace di azione militare integrata, incapace di scelte diplomatiche unite e coese, incapace di rispettare le proprie stesse decisioni. Sconta manifestamente la propria mancanza di sostanza politica. Non ha una visione strategica comune né sa proporre un’idea di pace con giustizia nel vicino Oriente. È un insieme di debolezze dei vecchi Stati, piuttosto che una forza attiva e propositiva.
Bene, quindi, la prudenza sull’ingaggio militare italiano che non solo è, ovviamente, non decisivo, ma che è politicamente insensato, in assenza di un pensiero politico e strategico comune. Grande attenzione, tuttavia, va posta al coinvolgimento progressivo, graduale e subalterno, nelle sabbie mobili del conflitto, a iniziare proprio da Mosul. Bene anche la consapevolezza delle carenze e della riluttanza dell’azione europea sui migranti, prima di tutto.
Ma il giudizio non può che essere di insufficienza sulla radicalità dell’analisi, che è mancata. Poco è stato detto dei rapporti economici relativi al traffico d’armi con molti Stati dell’area, dei flussi di denaro che affluiscono a Daesh. Poco dei nostri rapporti con Russia e Stati Uniti, attori ben più centrali della non esistente Unione europea.
Non solo, quindi, si deve implementare questa o quella politica sociale o di diffusione della cultura − ipotesi un po’ superficiale, in verità −, non solo si deve implementare il dialogo interreligioso, ma è necessario un ripensamento radicale delle mancanze politiche della costruzione dell’Unione europea come è oggi. Mancanze strettamente connesse al modello sociale ed economico che abbiamo adottato a scatola chiusa, al rapporto sbilanciato che l’Europa conosce fra l’economia − che è decisiva, ma governata dagli Stati nazionali − e la politica, che a livello europeo è ridotta a mera tecnica burocratica. Mancanze che rendono la posizione del governo poco credibile, e che ci dicono che l’iniziativa politica italiana dovrà essere ben più incisiva e radicale di quelle che ci sono state prospettate.
Riforma del Senato e legge elettorale
Intervento alla Camera dei deputati, 3 dicembre 2015
Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per il gruppo Sinistra Italiana sul complesso degli emendamenti relativi all’articolo 39 per esercitare una critica dell’intero provvedimento in continuità con le posizioni che a suo tempo ho espresso nel gruppo parlamentare del Partito Democratico.
Il provvedimento rappresenta un grande pasticcio, zeppo di confusioni richiamate e illustrate da molti colleghi nel corso dei dibattiti precedenti. Illustro per sommi capi.
Nell’articolo 1 è evidente la mancata chiarezza, sia riguardo alle funzioni proprie del Senato, sia riguardo alle funzioni di raccordo di questo rispetto alle istituzioni nazionali ed europee, sia, ancora, riguardo alle sue funzioni di valutazione delle politiche pubbliche.
A queste difficoltà e a queste confusioni si aggiunge il pasticcio relativo all’elezione dei senatori nell’articolo 2. Lì si stabilisce un rapporto non chiaro tra una fase elettorale nella quale sono protagonisti i cittadini e una fase elettorale interna alle istituzioni. Il raccordo è dato dal termine «conformità» che, preso sul serio, farebbe dell’elezione regionale un doppione della scelta dei cittadini, mentre, invece, il successivo riferimento alla «composizione del consiglio regionale» sostanzialmente riporta l’elezione dei senatori in capo ai consigli regionali e alle loro specificità, ad esempio alla loro formazione con leggi elettorali premiali, con il risultato che non sono chiare, né la via di composizione reale del Senato, né la fonte originaria di legittimità dei consiglieri trasformati in senatori. Un passaggio dal bicameralismo paritario al bicameralismo zoppo, insomma.
Questo garbuglio fa quindi sì che, mentre peraltro permane la Conferenza Stato-regioni, il Senato sarà di incerta composizione. Per di più, la sua composizione sarà instabile, soggetta com’è alla rotazione per le diverse scadenze delle assemblee regionali.
Infine, il Senato, le cui competenze non sono proprio nulle, darà luogo a contenziosi infiniti nel corso del complicato processo legislativo disegnato da questa riforma; un processo complessivamente connotato, da una parte, da debolezze e contraddizioni e, dall’altra, da un nuovo centralismo.
Queste confusioni e queste contraddizioni sono però al tempo stesso chiarissime. La riforma si inserisce, infatti, in un disegno complessivo del quale fa parte anche la legge elettorale; un disegno tutt’altro che provvisorio, come, invece, si è cercato di sostenere, quasi fosse cosa normale, ragionevole e priva di controindicazioni impegnare il Parlamento in tentativi di Costituzione, in Costituzioni ipotetiche, in prove di Costituzione, da perfezionare e da modificare poi alla bisogna.
Ciò non è normale né ragionevole, ma è purtroppo già avvenuto. Infatti, al contrario di quanto si dice, di riforme della Costituzione negli ultimi anni – non negli ultimi settanta né negli ultimi quaranta, ma negli ultimi quattordici anni e dunque limitatamente al XXI secolo – ne sono state fatte fin troppe: nel 2001, nel 2005, nel 2012 e anche ora, e tutte con esiti quantomeno discutibili. Quello che manca al Paese, insomma, non è il riformismo costituzionale, ma una precisa direzione di esso: una direzione negli ultimi quattordici anni ondivaga e ora, purtroppo, chiara – nonostante la mancata chiarezza di questa riforma trasandata e al contempo ben mirata –.
La direzione è il disegno complessivo, caso unico nel panorama delle democrazie parlamentari, di un governismo molto forte, di un cripto-premierato volto a ridurre il peso politico dei corpi intermedi e delle istituzioni rappresentative, a neutralizzare il Senato senza però abolirlo, a consegnare sostanzialmente la Camera al vincitore delle elezioni, a fare di questo il dominus dell’intero sistema politico e istituzionale – compresa la deliberazione dello stato di guerra –, ad avvicinarlo al controllo delle istituzioni di garanzia.
Si tratta senza dubbio di un disegno riformatore, ma di una riforma che va nella direzione opposta a quella che sarebbe stata desiderabile. Sarebbe stata desiderabile una riforma che avesse previsto un Senato delle garanzie che rilanciasse e ampliasse la democrazia prevista dalla Carta del 1947, la democrazia della partecipazione e della centralità politica del Parlamento, non la democrazia di investitura, che presto può divenire democrazia plebiscitaria.
Di questo disegno politico è prova il contenuto della Costituzione riformata, ma è prova anche l’origine politica di questa riforma costituzionale di potentissimo e decisivo impulso governativo, nonostante la variabilità delle alleanze che sono intervenute su questo tema. Il governo mette in questa riforma una buona parte della propria legittimità, in una vera esondazione dell’esecutivo, che, nella sua determinazione ad andare avanti a ogni costo, anticipa ciò che avverrà a Costituzione e a legge elettorale modificate.
Di questo disegno è prova anche l’iter parlamentare della riforma, segnato nelle Aule e nelle Commissioni da innumerevoli strappi e forzature, che non enumero proprio perché tutti le abbiamo vissute, e ne è prova anche il fatto che viene approvata solo dalla maggioranza di governo, gonfiata oggi dal Porcellum come domani lo sarà dall’Italicum. Altro che spirito costituente! Poco possono ormai, davanti a questi esiti, gli emendamenti presentati in questa sede, emendamenti che pure abbiamo difeso e difendiamo con convinzione nell’ottica della riduzione del danno.
La lotta democratica contro questa Costituzione dovrà ormai uscire dal Parlamento e svilupparsi nel Paese fino al referendum. È una lotta di cui saranno protagonisti gli italiani, che francamente non meritano una Costituzione così deturpata.
Contro la «buona scuola»
Intervento alla Camera dei deputati, 9 luglio 2015
Signor presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il voto difforme rispetto al mio gruppo, anche a nome di altri colleghe e colleghi.
Per motivare un voto contrario si possono invocare ragioni di metodo e di merito. Alle prime va ascritta la circostanza che contro la cosiddetta «buona scuola» si è mobilitato l’intero mondo della scuola, e questo avrà pure il suo valore. E che questo provvedimento è stato sottratto alla libera discussione del Senato, e anche alla promessa e mai convocata giornata di ascolto nazionale, e che contiene inoltre troppe deleghe.
Fra le questioni di merito si segnala il permanere di poteri discrezionali in capo al dirigente scolastico, il finanziamento privato delle scuole statali e di quelle paritarie secondarie, la discriminazione nelle assunzioni. E soprattutto una visione della scuola venata di leaderismo e di aziendalismo, centrata su una valutazione incompleta e al tempo stesso volta a creare disuguaglianza, e carente di un’idea critica e democratica di cultura e di formazione.
Per questi motivi, e per altri che non c’è tempo di esporre, voterò insieme ad altri, contro questo provvedimento.
La riabilitazione militare dei soldati fucilati per motivi disciplinari durante la Grande guerra
Intervento alla Camera dei deputati, 20 maggio 2015
Signora Presidente, onorevoli colleghi, come sappiamo, la Costituzione, all’articolo 11, afferma che l’Italia ripudia la guerra. Ora, ripudiare significa allontanare da sé − facendogli fare un passo indietro − qualche cosa che ci è appartenuto, qualche cosa che era nostro diritto esercitare. Conosciamo bene i motivi per cui quell’articolo è stato redatto in quel modo: perché la guerra ha fatto parte, inevitabilmente, della storia d’Italia.
Chi ha scritto quell’articolo aveva in mente primariamente quella che noi definiamo la Seconda guerra mondiale. Noi, oggi, stiamo applicando quell’articolo a un passaggio particolarmente doloroso della Prima guerra mondiale, guerra che ha fatto parte costitutiva della costruzione della nostra identità nazionale, nel male – naturalmente -, nel dolore infinito, nella sofferenza indicibile di quattro anni di tensione, quattro anni di sangue, quattro anni di violenza.
Nella Prima guerra mondiale lo Stato moderno ha raggiunto il massimo della propria capacità di comando sopra le popolazioni. Ha raggiunto l’apice della propria capacità di spingere gli uomini a vivere e a morire, della propria capacità di inquadrare, irreggimentare, motivare i cittadini verso un fine politico che a quei cittadini sfuggiva.
Una prova di forza che si è rivoltata contro lo Stato stesso, il quale, dopo la Prima guerra mondiale, ha cambiato profondamente la propria natura, diventando uno Stato ora democratico, ora totalitario, a seconda delle circostanze, e uscendone in qualche modo sfigurato.
In quella immane sofferenza, da cui è nato il XX secolo, con le sue caratteristiche peculiari, ciò di cui questa proposta di legge si occupa raggiunge veramente il diapason. Qui siamo davanti a una violenza di Stato che non consiste nello spingere le masse nazionalizzate alla guerra verso il nemico esterno.
Qui siamo davanti ad una violenza comminata dallo stesso Stato nei confronti dei propri concittadini. Comminata, ed è un’aggravante, secondo norme giuridicamente valide dal punto di vista della loro legalità formale. Una violenza esercitata dallo Stato stesso verso i propri concittadini a scopo intimidatorio, come avete sentito; a scopo non di giustizia, ma di propaganda.
Una delle forme attraverso le quali veniva realizzata la nazionalizzazione delle masse, l’irreggimentazione del popolo, era – oltre alla propaganda recitata – la propaganda detta, la propaganda scritta, questa sorta di propaganda armata, realizzata in forme pseudo-legali dalla stessa autorità dello Stato. Essere uccisi dalle pallottole austriache, ed essere uccisi dalle pallottole italiane è per certi versi la stessa cosa.
Ma, sotto un profilo specifico, essere uccisi dalle pallottole di un plotone d’esecuzione italiano è molto peggio. Molto peggio, perché vuol dire che in quella bufera, in quella tragedia, che è stata la Prima guerra mondiale, si perdeva, come infatti è successo, la capacità di distinguere il giusto dall’ingiusto, l’amico dal nemico. Il che vuol dire che in quella violenza collettiva era stata perduta la ragione. Ora noi, attraverso queste proposte di legge, facciamo sì che la politica si riappropri del proprio primato, della propria capacità di governare e di dirigere le cose umane, le cose della nostra Repubblica. In questo caso, attraverso un atto supremamente politico, come è l’atto che si compie in quest’Aula, l’atto della legislazione ad opera dei rappresentanti del popolo sovrano.
Noi, oggi, ripudiamo non la guerra in generale, non solo la guerra in generale. Ripudiamo quella guerra all’interno della guerra, che è stata il sistema della messa a morte pseudo-legale dei soldati italiani per motivi disciplinari a scopi intimidatori. L’Italia, in questo modo, mentre allontana da sé questa parte di quella guerra, si riappropria della sua storia. È in grado, in questo modo, di riconoscersi – rifiutando quella pagina specifica – con minore difficoltà nel proprio passato. Noi oggi facciamo un’operazione politica – sottolineo – perché attraverso la nostra forza politica, la forza del potere legislativo, modifichiamo le norme del codice militare di pace, del codice penale, per quanto riguarda l’ammissibilità del procedimento di riabilitazione.
Non interveniamo, ovviamente, sui casi specifici, perché non vogliamo interferire con l’ordine giudiziario e la sua capacità di decidere caso per caso, e facciamo un’operazione altamente politica, in questo caso altamente simbolica, perché nel momento in cui non scegliamo di perdonare queste persone fucilate, ma le vogliamo riabilitare, ci rendiamo conto, dimostriamo e dichiariamo che di perdono, semmai, ha bisogno lo Stato italiano e non questi suoi sventurati cittadini.
Dico questo perché le forme della riabilitazione dei soldati fucilati per motivi disciplinari sono piuttosto complicate. Nel mondo anglofono si è perseguita la linea del perdono, cioè si è dato per scontato che esistesse una colpa, che esistesse un reato, che viene perdonato oggi per ieri. Noi abbia scelto un’altra via, quella della riapertura dei casi, dei singoli casi giudiziari. Questo – ripeto – ha un valore politico estremamente alto, perché significa che non ci mettiamo al di sopra di questi cittadini, ci mettiamo quanto meno alla pari e vogliamo dare ad essi, una volta tanto, veramente giustizia, non per grazia, ma perché a loro è dovuto, restituendogli l’onore.
Non sarà semplice, ma non sarà nemmeno difficilissimo. La ovvia concomitanza di questo nostro atto legislativo con il centenario dell’entrata dell’Italia nella Prima guerra mondiale è il motivo contingente che ci fa essere qui con tanta urgenza. La nostra capacità di riconciliare noi stessi con la nostra storia passa, in modo assolutamente inequivocabile, attraverso la nostra capacità di conciliare questi nostri cittadini che ci chiedono giustizia, con la nostra idea di politica che è evidentemente assai lontana da quella autoritaria, spietata, irrispettosa dei diritti del cittadino prima ancora che dell’uomo, che informò quella pagina tragica, che noi oggi vogliamo voltare definitivamente.
Deliberazione dello stato di guerra da parte del Parlamento – riforma della Costituzione
Intervento alla Camera dei deputati, 13 febbraio 2015 (seduta “fiume” dell’11 febbraio 2015)
Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti relativi a questo articolo provengono da varie parti politiche. Alcuni sono trasversali e coinvolgono una parte del Partito Democratico, SEL, il MoVimento 5 Stelle ed il gruppo dei parlamentari per la pace.
Questi emendamenti affrontano un problema che nasce intorno all’articolo 78 – quello che recita «il Parlamento delibera dello stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari» – per la concomitanza della riforma della legge elettorale e della riforma della Costituzione. Il problema sta nel fatto che il combinarsi di queste due riforme fa sì che la deliberazione dello stato di guerra sarà a disposizione di una maggioranza parlamentare che non corrisponderà alla maggioranza reale dei cittadini votanti.
Prima di chiarire questo problema bisogna ricordare che la guerra della quale qui stiamo parlando non è né la lotta al terrorismo, né consiste nelle missioni internazionali, né nella partecipazione alle operazioni della NATO. E neppure è la risposta militare immediata ad un attacco. È invece – la guerra di cui si sta parlando – una precisa condizione di diritto internazionale fra Stati sovrani, una condizione che ha anche importanti effetti giuridici interni. La Camera conferisce al governo i poteri necessari. Si può impedire, con legge, il rinnovo delle Camere, cioè si bloccano le elezioni politiche, ed il codice penale militare di guerra non è ricorribile in Cassazione. Dobbiamo inoltre ricordare che, per l’Italia, secondo l’articolo 11 della Costituzione, primo comma, la guerra può essere soltanto difensiva, o può derivare dall’appartenenza dell’Italia ad un’organizzazione difensiva. Quindi, sotto il profilo pratico, quello di cui stiamo parlando è un caso raro. E tuttavia è una importantissima questione di principio: infatti, la deliberazione sullo stato di guerra è uno degli aspetti fondamentali dell’esercizio della sovranità popolare.
Tutto ciò premesso, il problema lo si affronta sciogliendo un dilemma: se la guerra sia materia di governo o sia materia di Parlamento. Se è materia di governo, non c’è alcun problema; se invece non è materia di governo, il problema nasce. Allora, una semplice analisi dell’articolo 78 ci fa capire che il governo non è il soggetto propositivo della deliberazione dello stato di guerra. L’articolo 78 non dice che il Parlamento delibera lo stato di guerra sentito il governo. Il governo compare, nell’articolo 78, esclusivamente come destinatario di poteri speciali, ancorché indeterminati.
Il significato di questo meccanismo è il seguente. Il Parlamento delibera lo stato di guerra e il governo conduce la guerra, dopo che il Capo dello Stato l’ha dichiarata ex articolo 87. Dunque, in quanto materia autonoma del Parlamento, la deliberazione dello stato di guerra significa che questo stato di guerra è parte della sovranità del popolo. Questo è evidentissimo nella Carta sotto il profilo storico, in quanto i costituenti stavano reagendo alla dittatura fascista e all’assoluta autocrazia con la quale l’Italia era entrata in guerra, e stavano reagendo contro lo Statuto Albertino che, nel suo articolo 5, dava al Re – in quanto capo dell’esecutivo – il potere di dichiarare la guerra. Dunque era una scelta – quella dei costituenti – quella di dire che la guerra appartiene alla sovranità del popolo e il Parlamento delibera su di essa.
Dunque, abbiamo il principio di sovranità popolare, il principio di rappresentanza – il popolo non delibera la guerra tramite un plebiscito ma attraverso il Parlamento –, e il principio di maggioranza. É necessaria la maggioranza del popolo per dichiarare la guerra. È evidente, infatti, – ed è noto sino dagli inizi degli anni Cinquanta alla dottrina – che la Costituzione italiana incorpora implicitamente, ma chiaramente, il sistema elettorale proporzionale.
Ora, e siamo venuti al punto, quando la nuova legge elettorale sarà a regime, la maggioranza di governo non rappresenterà la maggioranza dei cittadini, ma soltanto, eventualmente, il quaranta per cento. Ora, noi possiamo accettare che, per l’ordinaria opera di legislazione e per consentire al governo di implementare il proprio programma elettorale, si dia una prevalenza all’elemento della governabilità rispetto all’elemento della rappresentanza, purché questa prevalenza sia moderata, sulla base di quanto dice la sentenza della Corte costituzionale del gennaio dell’anno scorso.
Ma – è questo il punto – qui non si tratta della ordinaria legislazione, né di conferire al governo la possibilità di realizzare il proprio programma elettorale. La guerra, questa guerra in forma, è un evento straordinario, un vero e proprio caso di eccezione. E allora, in quanto esercizio, benché mediato, della sovranità popolare, è evidente che in questo caso deve prevalere il principio di rappresentatività, e che il Parlamento, per deliberare sullo stato di guerra, deve farlo attraverso un quorum che implichi, almeno teoricamente, la maggioranza dei cittadini.
Sotto il profilo dell’esecutivo, poi, faccio notare che, nei casi di guerra classici che noi conosciamo del XX secolo, nelle democrazie le guerre vengono condotte da gabinetti di guerra che comprendono tutti i partiti. Dunque è questo il motivo per il quale il quorum della deliberazione deve andare oltre il cinquantacinque per cento degli aventi diritto, che è garantito al governo dalla nuova legge elettorale. Ed è quindi questo motivo anche per il quale mi pare che non risolva nulla, se non esclusivamente sia un segno simbolico, concedere che la deliberazione sullo stato di guerra avvenga non a maggioranza semplice ma a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Detto in altro modo, insomma, quello che si tratta di evitare è che la maggioranza di governo sia il dominus della guerra. Del resto lo stesso tema si è posto per l’elezione del Capo dello Stato, sulla quale in effetti i quorum necessari sono stati innalzati proprio in previsione dell’entrata in vigore della nuova legge elettorale. Questo sotto il profilo, per così dire, teorico e storico.
Sotto il profilo pratico, poi, forse sarebbe bene ricordare che in un futuro – auguriamoci remoto – la maggioranza di governo potrebbe anche non prevedere la presenza al governo del Partito Democratico. Dunque nel complesso meccanismo di riforme che noi abbiamo posto in essere con questo meccanismo – che ha come tratti fondamentali il rafforzamento dell’esecutivo, la speditezza della vita politica e la forza decisionale del governo – non sta per niente male un elemento di garanzia, non tanto per i partiti politici, quanto per il popolo. Un elemento di garanzia che la dichiarazione formale dello stato di guerra non sia nelle mani di un partito, ma sia nelle mani della parte maggioritaria dei cittadini della Repubblica italiana.
Del resto – e mi avvio alla conclusione – è un’affermazione di Kant, in Per la pace perpetua, uno dei testi classici dell’illuminismo, che in una Repubblica la deliberazione sullo stato di guerra può avvenire soltanto con il consenso della popolazione.
Richiesta di un’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma
Intervento alla Camera dei deputati, 24 giugno 2013
Signor presidente, onorevoli colleghi,
la nuova situazione determinatasi in virtù dell’entrata in vigore della legge 244 dicembre 2012, soprattutto dell’art. 4, consegna al Parlamento la responsabilità primaria, in interazione dialettica con il governo, non solo dell’analisi della situazione geopolitica internazionale, delle sfide strategiche che sovrastano il nostro Paese, e della valutazione delle opportune misure per fronteggiarle, ma anche dei singoli sistemi d’arma, dal punto di vista operativo e delle compatibilità economiche.
Il nesso fra politica e armi, fra politica e politiche della difesa e della sicurezza, dunque, si stringe; la pretesa autonomia della tecnica e degli specialismi cede il passo alla valutazione, alla decisione e al controllo della politica democratica. Il potere politico nella sua forma istituzionale più alta, in questa Camera in cui la sovranità popolare si rappresenta, afferma la propria superiorità su ogni altro potere e su ogni altro interesse, su tecnostrutture e complessi militari-industriali. Difesa e sicurezza sono concetti politici, su cui la discussione pubblica è non auspicabile ma doverosa.
È dunque con legittima soddisfazione per questo grande risultato, che dobbiamo sempre più valorizzare, che oggi cogliamo una grande opportunità e affrontiamo una grande sfida. La questione sollevata dall’opposizione, e ben presente anche al Pd, affida al parlamento e a questa Camera il compito, oggi urgente come non mai, di conoscere per deliberare, in piena libertà e piena consapevolezza, su ogni aspetto degli interessi permanenti del paese e sulla loro possibile armonizzazione.
Si tratta di interessi interni, tanto rilevanti da coinvolgere la stessa tenuta democratica della società, come l’esigenza di fronteggiare la crisi economica in presenza di una drammatica scarsità di risorse pubbliche, oltre che private. L’esigenza, cioè, di dare una risposta politica, credibile e rapida, a un bisogno di lavoro che è anche un bisogno di speranza. Un’esigenza che non può essere mortificata, pena l’ulteriore discredito delle istituzioni, da spese inutili o avventate o scarsamente giustificabili, quale che sia l’ambito coinvolto.
E si tratta poi degli interessi esterni, di quelli cioè che nascono dal fatto che il nostro Paese è collocato in un contesto internazionale, di opportunità ma anche di crisi e di minacce. È ormai nozione comune e condivisa che la complessa serie dei fenomeni e dei processi che vanno sotto il nome generico di globalizzazione sia portatrice anche di rischi difficilmente controllabili, che sfidano le strutture ordinative internazionali. Rischi mobili, dinamismi potenti e sfuggenti, al cui pacifico controllo l’Italia contribuisce con la sua azione internazionale, volta alla costruzione di un sistema globale in cui l’ingiustizia e l’oppressione abbiano meno spazio di quanto oggi non accada. Politica è anche questa azione, volta a modificare, nella direzione della giustizia e della civiltà, l’ambiente storico politico ed economico internazionale.
L’ambiente italiano è soprattutto il Mediterraneo allargato (fino all’Oceano indiano orientale), dal quale dipende di fatto la nostra economia. È un’area segnata profondamente da un arco di crisi complesse − economiche politiche religiose demografiche − che non si può certo pensare di risolvere con strumenti militari ma dal quale non si può pensare di chiamarsi fuori. È piuttosto necessario che l’Italia sappia coniugare la proiezione di cooperazione (il modo normale di funzionamento della nostra azione internazionale) con l’eventuale proiezione di forza, insieme agli alleati e nel quando della legalità internazionale, contro le minacce.
Del resto, è la nostra Costituzione a prescrivere che l’Italia sia un Paese pacifico, che rinunci alla guerra come aggressione alla libertà altrui e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11). Un’autolimitazione dello jus ad bellum, come sovrana disponibilità all’uso della forza, che la coscienza mondiale, almeno dalla grande guerra, ha maturato universalmente, e che è la condizione per la stessa esistenza dell’organizzazione delle Nazioni Unite.
Nondimeno, resta all’Italia, come Paese sovrano che si colloca all’interno di un sistema di alleanze consolidate e in un’ottica europea e occidentale, il dovere di proteggere i suoi cittadini dalle minacce alla vita, ai beni, all’ordinato svolgimento della vita democratica, allo sviluppo economico del Paese. A questo dovere essenziale dello Stato e dei cittadini di garantire gli interessi nazionali fanno esplicito riferimento gli artt. 52 e 78 della Costituzione.
L’analisi e la valutazione delle molte e diverse minacce, e quindi delle molte e diverse misure e modalità per farvi fronte, è una permanente attività di conoscenza e d’azione di uno Stato. In questo momento, e in queste circostanze, un’indagine conoscitiva condotta dalle commissioni parlamentari competenti, con piena libertà, sulle prospettive strategiche del Paese, sulla sua sicurezza in senso lato − cioè politico −, e quindi anche sui sistemi d’arma da adottare, tenuto conto della presente situazione economica, delle alleanze in cui ci collochiamo e delle esigenze di interoperabilità che ne seguono, è la migliore risposta − preoccupata e responsabile, ma non emotiva né demagogica − ai legittimi interrogativi dell’opinione pubblica, che il Pd fa propri con forza e determinazione.
Che la politica, senza accettare nessun fatto compiuto, e senza nessuna timidezza, ma con grande realismo e con grande spirito democratico, si faccia carico di un’ampia indagine conoscitiva sulle esigenze complessive della sicurezza e della difesa nazionale, e non di un solo sistema d’arma ma dei principali, non può che rafforzarne la legittimità agli occhi dei cittadini e dell’opinione pubblica. È quindi non può che essere un segno della vitalità della nostra democrazia.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.